Che cos’è il carcere.
Pubblicato: novembre 26, 2020 Archiviato in: Carcere, Lotte, Repressione, Uncategorized | Tags: Carcere, Lotte Lascia un commento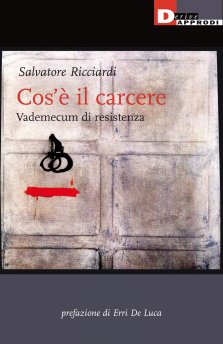
(La scomparsa del Salvatore Ricciardi nella primavera del 2020 è stata una perdita inestimabile per la coscienza morale e civile dell’Europa, il meno che si possa fare è mantenere vivo il dibattito sulle sue idee. La recensione che segue è stata già da me, pubblicata altrove, molto tempo fa, tuttavia mantiene tutta la sua attualità)
Ci sono molte esperienze, in vario grado “incomunicabili”, ossia esperienze che non possono essere efficacemente descritte a chi non le ha provate. L’esperienza della detenzione è tra queste. Salvatore Ricciardi, il quale è passato attraverso numerose esperienze di lotta per approdare alle Brigate Rosse e per sopravvivere a una lunghissima detenzione senza mai pentirsi nè dissociarsi, nella sua opera “Cos’è il carcere. Vademecum di resistenza”(1), prova a fornire una descrizione del carcere e contemporaneamente a dare a chi legge qualche idea su come sopravvivere psicologicamente a questa esperienza. Lo fa partendo dal suo “ritornare” al carcere da libero, chiedendosi esplicitamente quali siano le ragioni di questo ritorno. Domanda che troverà una sua compiuta risposta solo alla fine del libro, tra descrizioni di esperienze personali dell’autore, citazioni di opere di altri, e lettere dal carcere, di ieri e di oggi.
L’opera procede in modo assolutamente non lineare, alternando analisi, riflessioni, ricordi su temi e “su piani” diversi. Diversi temi ricorrono ciclicamente, vengono proposti per poi venire momentaneamente accantonati solo per ritornare “ampliando il discorso”. Si potrebbe, con una certa libertà descrittiva, paragonare la scrittura del Ricciardi in questo testo, alle opere liriche di Wagner, con leit-motiv che ritornano, ampliati, in chiavi diverse etc.
L’autore al principio analizza la sofferenza e la nozione di “accettabilità” di una sofferenza: “Quanto sia <<accettabile>> una sofferenza lo può decidere solo chi la subisce; ciascuno ha il suo limite che non è misurabile.” (2). Un nodo fondamentale è quello del concetto di tempo, il tempo ha una sua dimensione storica che deve far riflettere sulla transitorietà stessa del carcere, ma che per il soggetto che è detenuto è sperimentato come immobile, anche se si possono individuare dei momenti particolari come ad es. Il momento dell’arresto. Di qui anche il tema del ritorno al carcere: “Ci torni [in carcere] perchè quando ne hai fatta tanta di galera, e le sei stato ostile, tra te e lei si è aperto uno scontro mortale: o tu o lei. E’ una sfida che riguarda tutti i <<bravi ragazzi>> [termine del gergo carcerario che l’autore spiega come definente i detenuti solidali e ostili al carcere] e termina solo con la morte di una dei due.” (3). Un certo spazio è dedicato alle sensazioni fisiche, sapore, odori etc. Alla presenza degli altri, all’udito, alla cura di sè che più avanti nel libro viene quasi presentata come uno strumento di sopravvivenza. “Ma qui, in galera, ogni sensazione si tinge di colori forti. Gli stessi colori del ferro delle sbarre e della porta blindata”(4). In carcere, anche se vivi in mezzo agli altri, sei solo. Solo partendo da questo si può esaminare le relazioni tra detenuti.
“L’unica cura è ancorarsi alla concretezza dell’odio verso il carcere pensando, progettando e producendo rivolte o evasioni. E’ l’unico modo per restare sani, per evitare di essere stritolati dalla galera.”(5). Anche di qui l’esame del carcere procede su diversi piani, tra l’esame del suo ruolo sociale, i rapporti con il mondo “produttivo”, e di nuovo si affronta da più “prospettive” il problema del tempo e dei metodi per sopravvivere all’immobilità di questo in carcere: “Il tempo lo prende in consegna il carceriere”(6). E’ solo quando nel carcere scoppia una rivolta che il detenuto vive un tempo analogo a quello dei non-detenuti.
L’identità soggettiva è data (anche) dalle relazioni; Ricciardi illustra come la detenzione distrugga (almeno in parte) l’identità del soggetto precedente all’esperienza detentiva: “Prima di ogni altra condanna scatta il tempo della degradazione. Prima quella sociale, poi quella individuale” (7). L’autore ritorna poi al rapporto tra il detenuto e il proprio corpo, con uno sguardo quasi da antropologo parla delle auto-mutilazioni, dei tatuaggi, dell’urlo delle rivendicazioni corporee che in carcere diventano dominanti. E riflette (di nuovo) sulla sofferenza: “La sofferenza divide, non è vero che la sofferenza accomuna. Se soffri ti dà fastidio qualsiasi presenza, a meno che non sia totalmente dedicata ad accudirti e confortarti per lenire la tua sofferenza” (8).
Come contrastare l’annientamento? Il metodo implicitamente ed esplicitamente sostenuto dal Ricciardi è la rivolta, sia individuale sia soprattutto, collettiva: “Quando il carcerato cessa di essere ripiegato su sé stesso e, insieme ad altri, combatte la sofferenza che lo isola, inizia un percorso collettivo di contrasto all’annientamento” (9). Poi esistono metodi secondari e piccole regole.
Ci sono differenze tra carcere e carcere: “L’obbiettivo però è lo stesso: debilitare il corpo per sottomettere la volontà”(10). Questo viene perseguito in vari modi ma “anche Gramsci nelle sue lettere dal carcere annotava che il sistema carcerario <<manifesta la sua crudeltà non in efferatezze o sadismi, bensì nel tran-tran burocratico della detenzione, delle piccole vessazioni…>>” (11).
Un’altro elemento importante dell’esperienza detentiva è l’assenza di comunicazione da parte dei detenuti soprattutto verso l’esterno del carcere. E’ il carcere invece che si espande verso l’esterno, mentre una forma molto crudele di tortura carceraria è la “deprivazione sensoriale” impiegata nell’ex Germania Ovest.
Il carcere è uno strumento unicamente repressivo, mai però separato dal resto dello “sfruttamento produttivo”. Conclude il volume un dizionarietto dei termini del gergo carcerario, ma prima di questo, come conlusione, riporto le parole dell’autore che chiudono l’opera: “Ora ho capito il vero motivo di questo ritorno. Sono tornato in carcere per sentire di nuovo il sapore acre dell’odio verso la galera, per esserne di nuovo contagiato, non per portarlo via. [….] Sentirsi liberi di <<sciegliere>> di poter odiare il carcere, e la struttura sociale che lo produce e lo riproduce, è parte fondamentale della lotta per la libertà […..] L’odio verso il carcere ci aiuta a individuare i veri nemici e lottarci contro. La battaglia contro il carcere va intensificata con la convinzione che stavolta non siano i detenuti a soccombere ma il carcere. Che finisca! Che venga abolito![…]”(12)
(1) Salvatore Ricciardi, Cos’è il carcere. Vademecum di resistenza, ed. DeriveApprodi, Roma 2015
(2) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 13
(3) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 19
(4) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 28-29
(5) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 39
(6) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag.48
(7) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 54
(8) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 60
(9) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag.69
(10) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 76
(11) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 81
(12) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag.97
La Repressione, tramite la legge, del Minorenne
Pubblicato: novembre 29, 2013 Archiviato in: Carcere, Lotte, Repressione | Tags: Carcere, Lotte, Repressione Lascia un commento(Questo articolo è stato pubblicato alcuni anni fa, sulla rivista “Lo Scomodo”. Dato che la suddetta rivista non esiste più, ma che l’articolo, benchè ormai “datato”, non ha perso completamente di attualità, ho creduto opportuno ripubblicarlo, con minime correzioni. Comunque, quando si parla di “comunità” ci sono alcune imprecisioni, che sono troppo pigro per correggere)
La struttura repressiva “par excellence” per i minorenni, non è il carcere bensì la famiglia. Non tratteremo questo aspetto della questione, anche se, come vedremo, ciò è ampiamente riconosciuto (“de jure”) dalla legge. Dove finisce l’azione della famiglia comincia quello della polizia. Qui inizia la nostra indagine. Cominciamo col dato empirico che il minorenne in stato di fermo o di arresto, specie se accusato di crimini “violenti”, ha probabilità molto maggiori dell’analogo maggiorenne di essere soggetto di abusi, specialmente se extracomunitario, clandestino, o apolide. I suoi diritti sono (“de facto”) comunque minori: se denuncia un abuso difficilmente è creduto, la sua testimonianza ha minore peso, si hanno meno riguardi etc. Tribunale e magistrato per i minori sono formalmente separati da quello ordinario. La discrezionalità del magistrato, per quanto riguarda i minorenni, è amplissima, è non è mai chiara la linea di confine tra abuso e azione legittima. Nello spirito delle attuali norme, il carcere per i minorenni dovrebbe essere una sorta di estrema risorsa repressiva a disposizione del magistrato. Prima di giungere a quello si tenta con l’affidamento alla famiglia, o ad una comunità, (utilizzate quindi come strumenti repressivi). Esiste anche l’istituzione della cosiddetta “messa in prova”, lasciandolo o ponendolo all’interno, ancora, della famiglia, o della comunità. Prima di ricorrere al carcere, o dopo una permanenza “x” in esso, si “prova” se il soggetto “delinqua” ancora o meno, impiegandolo in lavori che vengano definiti come “socialmente utili”. Anche il “metodo sperimentale” ha trovato la sua grottesca applicazione nel campo. La famiglia, definita secondo i canoni del cristianesimo (ideologia dominante), è riconosciuta dalla legge come la “prima istanza” repressiva. Non sempre però il magistrato ritiene la famiglia efficace oppure volenterosa. Si può trattare di un nucleo familiare i cui membri siano disoccupati-nullatenenti, pregiudicati, detenuti, tossicodipendenti, clandestini, residenti all’estero o addirittura irreperibili (caso non così infrequente, specie tra i cosiddetti “nomadi”). In questi casi, per “qualsiasi sciocchezza” si può giungere in carcere (ad es. con l’uso della cosiddetta “custodia cautelare”) Ricordiamo che il magistrato in questione dispone di ampia discrezionalità, e l’affidamento alla famiglia di origine può venire rifiutato per un’ ampia gamma di ragioni, non sempre intellegibili. Diremo semplicemente che se la famiglia è di basso livello socio-economico, oppure di origini extracomunitarie, (o ancora: se i suoi membri sono ritenuti inaffidabili/irreperibili) è probabile che il magistrato non la ritenga idonea. Il secondo gradino è la comunità. Le comunità esistenti spaziano da strutture semplicemente costituite da un prete cattolico che aggiunga qualche letto alla sua sacrestia, fino a realtà gestite da associazioni e molto strutturate. Alcune di queste sembrano essere veri lager, in altre “l’ospite” viene (quasi) lasciato totalmente a se stesso. Non viene fatta alcuna differenza formale tra queste, ed è solo il caso (ma anche: la disponibilità di posti-letto nell’immediato) che determina la destinazione ad una o ad un’altra comunità. Non sempre il magistrato reputa il soggetto idoneo alla comunità. A volte (e questo rientra nella discrezionalità del suddetto magistrato) un soggetto x viene fatto stare y tempo in carcere e poi improvvisamente (buona condotta o meno) trasferito in una comunità. Enumeriamo alcune particolarità del carcere minorile, dando per scontato che il lettore o la lettrice siano al corrente delle pratiche generalmente in uso nelle strutture detentive, quali ad es. il mantenimento “sotto farmaci” dei soggetti più irrequieti. Le regole e la vita dentro il carcere minorile sono generalmente solo un pò migliori di quelle del carcere per “adulti”. Si hanno cortili più spaziosi, regolamenti più blandi, carcerieri senza uniforme. Un discorso a parte andrebbe fatto per quanto riguarda i farmaci, qui impiegati quasi esclusivamente in funzione repressiva. Un minore che entri in carcere viene (dopo formalità che il lettore può immaginarsi da solo) formalmente affidato ad un educatore. Ci sono educatori che “educano” altri che si considerano guardiani, altri ancora che non fanno alcunchè. Grosso modo possiamo dire che viene svolto l’obbligo scolastico, poi si fanno attività più o meno “formative”. Possiamo osservare che la vita dentro il carcere minorile è più “attiva” di quella dentro il carcere per adulti. Non necessariamente questo è un fattore positivo. Se il dettato costituzionale secondo cui la pena deve “rieducare” è di fatto disatteso per i maggiorenni, per quanto riguarda i minorenni, questo è strumentalmente utilizzato per giustificare qualsivoglia genere di oppressione, se non di abuso. Si giunge all’estremo di vedere inflitte punizioni corporali, perlopiù da parte degli agenti di custodia, con la scusante di voler “educare”. Ma anche senza voler giungere a questo, possiamo empiricamente osservare come “educare” sia, utilizzato come scusante per costringere, comandare, o quantomeno spegnere ogni barlume di individualità…Gli educatori sono sottoposti ad un educatore-capo, ed il magistrato visita saltuariamente la struttura (o almeno può visitare saltuariamente la struttura). I trasferimenti da carcere a carcere, come quelli da carcere a comunità, avvengono a discrezione del magistrato, tranne i casi di conclamata “incompatibilità ambientale” (generalmente tentativi di evasione). Empiricamente osserviamo che sono frequenti, e, di nuovo, spesso privi di ogni ragione intellegibile. Sembra che i legislatori abbiano voluto “traslare” l’autorità (in origine?) paterna della “patria podestà” sulla figura del magistrato. Le analogie sono inquietanti, e non gettano una buona luce né sulla famiglia né sui legislatori. Ultimamente sta prendendo piede l’abitudine di colpire qualsiasi comportamento “non appropriato” del minore (uso di alcolici, scritte sui muri, etc.), tramite sanzioni economiche, che chiaramente chiamano in causa la famiglia del soggetto. Questo ci riporta al punto di partenza ossia all’ uso repressivo della struttura familiare.