L’autunno tedesco
Pubblicato: settembre 6, 2022 Archiviato in: letteratura, Lotte | Tags: letteratura, Lotte Lascia un commento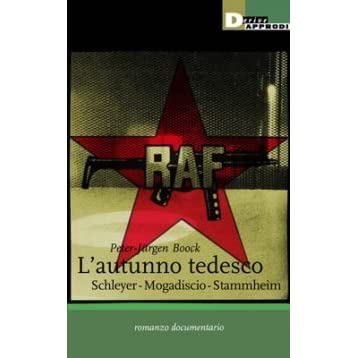
(ripubblicato qui, con varie aggiunte)
Quante volte, solo a distanza di anni, ci rendiamo conto dell’effettivo significato di una conversazione, di un discorso? E quante volte gli stessi protagonisti non si rendono conto di quello che stanno dicendo? E quante volte solo una terza persona può capire “il nocciolo del problema”? Persino molto al di là delle intenzioni dello stesso autore, quest’ultima domanda salta particolarmente in mente leggendo “L’autunno tedesco” di Peter-Jürgen Boock, “romanzo documentario” (in Italia edito dalla DeriveApprodi, Aprile 2003) che narra, nella prospettiva soggettiva dell’autore-protagonista, una pagina di storia tedesca ancora discussa. Il titolo si rifà al famoso documentario “Germania in autunno”. L’autore, dopo un’adolescenza problematica in cui sperimenta l’oppressione della famiglia e la violenza dello stato, viene a contatto con gli elementi che fonderanno la RAF (Rote Armee Fraktion, -frazione dell’Armata Rossa- gruppo rivoluzionario tedesco ). Al momento in cui questi ultimi verranno incarcerati, decide di darsi da fare per liberarli. Siamo nell’estate del ’76. Insieme ad altri, sequestra il presidente della confindustria tedesca, (Hanns-Martin Shleyer, già gerarca nazista, poi alfiere del capitalismo “mannaro” della Germania Occidentale del secondo dopoguerra) per usarlo come “merce di scambio” per ottenere la loro liberazione. Fin dal momento dell’agguato, il gruppo si trova ad essere succube degli eventi. Sulle soglie della consapevolezza di essere guidati dagli avvenimenti che si susseguono, piuttosto che esserne gli artefici (del resto, commento io, come tutti in qualsiasi situazione), i protagonisti si barcamenano alla meno peggio, nell’estema stanchezza, tra traslochi con l’ostaggio e trattative con le autorità. Risalta impevista l’umanità (non vogliamo chiamarla ordinarietà?) di tutti i coinvolti, da Shleyer, che si preoccupa della sorte che è toccata al suo autista (e questa è la prima domanda che pone al gruppo), ai “rapitori” , che si preoccupano continuamente dell’impressione che stanno dando all’”ostaggio” (fino al punto che una di loro verrà sorpresa a giocarci a monopoli). E di questo l’autore è assolutamente consapevole…Ma attraverso questa “banalità”, la figura di Shleyer (chiamato familiarmente “Spindy” dal gruppo ), malgrado i sensi di colpa ammessi dell’autore, filtra una luce diversa, potremmo dire “in filigrana”….Oggi, possiamo forse (?) vedere più chiaramente l’assenza di positività (ma anche, di necessità) dello sviluppo economico e industriale di cui “Spindy” tesse – senza venire realmente contraddetto- le lodi al gruppo….I cui componenti, pur intuendo confusamente la continuità – di cui “Spindy” è esemplare- tra passato nazista e presente (1977) “industriale”, non riescono proprio a trovare “il bandolo della matassa” e rimangono frustrati nelle loro intenzioni polemiche di fronte all’uomo in carne ed ossa; che risponde cordialmente alle domande, si mostra umanamente interessato agli operai, e non risponde alle provocazioni…Anche se lo stesso uomo nota con una certa sfrontatezza che “nel 1944 il paese toccò il suo massimo indice di produttività” (pag. 93) oppure rinfaccia agli interlocutori: “senza quella generazione, che non è responsabile solo dei crimini del nazismo, ma anche della ricostruzione di un paese distrutto, voi non ve la sareste passata tanto bene” (pag.77)….I “sequestratori” non riescono a contrapporgli che argomenti morali, di cui sono i primi a confessare la relatività…Dimenticando così i motivi concreti che li avevano portati fino a quel gesto. La contrapposizione tra di loro diviene quindi una contrapposizione di anime spinte dal destino. E qui apro una digressione, “con il senno di poi”. Se i paesi del “blocco orientale”, analogamente agli stessi Stati Uniti, potevano (e in qualche misura …) trovare una qualche giustificazione etica e morale al progresso industriale nell’esplorazione dello spazio, e -nel caso statunitense- nell’apertura in generale di “nuove frontiere”, lo sviluppo industriale della RFG (Repubblica Federale di Germania), la cosiddetta “Germania ovest”, appare -di nuovo “con il senno di poi” particolarmente povero di qualsivoglia giustificazione nelle sue azioni e omissioni. Questo non era un problema esclusivo della RFG , ma qui si parla di Germania. Persino la famosa contrapposizione alla RDT è difficile da concepire se non in un contesto di accesa “paranoia reciproca”, paranoia certo auto- indotta e funzionale al mantenimento di determinati equilibri, ma che noi “posteri” stentiamo davvero a credere “ragione sufficiente” di fronte a “bestialità” come l’esistenza -e persino lo sviluppo!- di “cose” come la Borsa di Francoforte. E che certo non ci sembra sufficiente a confronto con le sofferenze (e la schiavitù salariata) di milioni di persone (se esaminiamo solo l’area tedesco-occidentale) che ha portato. Ma, al di là delle “scuse morali” ( o della loro assenza), il richiamo costante alla concretezza dei fatti è la lezione che Marx non è riuscito a “passare” a molti suoi epigoni. Che così fanno “misera scena” di fronte ai più spudorati sostenitori “del vivere all’inferno perché così ci piace”. Fine digressione. La vicenda narrata da Peter-Jürgen Boock finirà in tragedia, malgrado tutti. Proprio nel “malgrado tutti” stà la grandezza del libro. L’autore “viene trasferito” in Iraq dove assiste impotente al tentativo di sbloccare la situazione tramite il dirottamento (in “coproduzione” con i palestinesi) di un aereo tedesco prima nello Yemen, poi a Mogadiscio (che finirà con la morte dei dirottatori), all’uccisione di “Spindy” (quando ormai i sequestratori avevano rinunciato a “processarlo” e ne riconoscevano una sorta di influenza morale sul gruppo), all’inesplicabile (suicidio o omicidio?) morte dei compagni in carcere che volevano liberare (che sembra “presa di peso” da qualche scena di Eschilo o di Sofocle), fino alla dispersione dei superstiti…Senza nominare i classici greci, Peter-Jürgen Boock, ne testimonia la perenne attualità.
La “banda 22 ottobre”, di Paolo Piano
Pubblicato: Maggio 21, 2021 Archiviato in: Lotte | Tags: Lotte Lascia un commento
Rientra nei “fatti storici” che uno dei primi “nuclei” a passare alla lotta armata, fù il cosiddetto “Gruppo XXII Ottobre” attivo a Genova (e dintorni) tra il 1969 e il 1971. Sulle vicende che li videro protagonisti sono stati scritti -o almeno: sono a conoscenza di chi scrive- due libri. Il primo è “Animali di periferia” di Donatella Alfonzo (1), che sebbene si avvalga anche delle testimonianze di alcuni dei protagonisti, ha visto “il ripudio” ufficiale da parte di uno degli intervistati (2). L’altro è quello di Paolo Piano “La <<banda 22 ottobre>> – Agli arbori della lotta armata in Italia” edito dalla casa editrice DeriveApprodi (3).
Il libro parte dall’episodio che segnò in pratica la fine della vita operativa del gruppo, ossia la rapina, o per essere più esatti dovremmo dire “lo scippo a mano armata” a scopo di finanziamento ai danni dell’istituto autonomo case popolari a Genova del 26 marzo 1971. Rapina finita male, con la morte di un portavalori. Le immagini della rapina, subito pubblicate, in una sequenza oltretutto arbitraria e tendente a colpevolizzare quello che in fin dei conti è stato un omicidio non voluto, scatenarono un vero e proprio “linciaggio mediatico”. Uno dei partecipanti, Mario Rossi, venne arrestato immediatamente dopo l’accaduto. Subito dopo viene arrestato un “perfetto estraneo” Salvatore Ardolino, solo sulla base del fatto che viene trovato intento a vestirsi da donna, e quindi sospettato di voler evitare la propria identificazione, poi costui confessa tutto quello che gli inquirenti vogliono, inventandosi tutto di sana pianta, e addirittura viene trovato positivo alla prova del “guanto di paraffina”, il che deve far riflettere sull’attendibilità di simili prove, dato anche che poi risulterà del tutto estraneo ai fatti.
Comunque le indagini proseguono, in un clima di “demonizzazione” anche da parte del Pci locale, e piano piano viene smantellato tutto il gruppo, che tra l’altro non si era neanche dato “un nome”; il nome 22 Ottobre lo dà a loro la stampa partendo da un biglietto ferroviario trovato nelle tasche di Mario Rossi, e questa rapina finita male viene collegata alle altre azioni del gruppo, o meglio ad alcune delle altre azioni del gruppo, perché ad esempio l’incendio di un camion militare americano -trasportante armi per i soldati americani in Vietnam- non gli viene attribuita dagli inquirenti perché magistrati e “benpensanti” chiamiamoli così, cercano in ogni modo di dipingerli come “delinquenti comuni” e di non dare risalto all’aspetto politico delle loro azioni. Sono interessanti e significative anche le interferenze realizzate dal gruppo sui programmi televisivi, realizzate confrontandosi dialetticamente con “altre idee” di Feltrinelli, una sorta di ” hackeraggio ante-litteram”, in cui (ma qui vado oltre il testo di Piano) possono essere considerati i precursori di azioni realizzate nei giorni nostri su internet.
Il Pci locale, dal canto suo cerca addirittura, almeno in un primo momento del processo, basandosi sul fatto che ad una delle azioni aveva collaborato un pregiudicato comune di chiare simpatie di destra, di farli passare come fascisti. E questo perché era profondamente scomodo per un Pci sempre più orientato quantomeno alla convivenza, per usare un termine moderato, con “lo status quo”, riconoscere che delle azioni di lotta , in realtà poi, secondo me, anche “non troppo violente” perché nel “curriculum” del gruppo troviamo soprattutto attentati contro “cose”e non contro “persone”, ma per il Pci locale stavo dicendo, era molto scomodo riconoscere che delle azioni “di lotta armata” fossero state portate avanti da degli elementi che perlopiù si erano formati o comunque “gravitavano” attorno al Pci.
Come scrive Franco Fratini nella sua introduzione all’opera, “All’inizio degli anni Settanta la Resistenza era finita da trent’anni, ma molti a sinistra sia fuori che dentro il Pci desideravano che quella lotta e quella guerra di liberazione venissero riprese e infine portate a termine, e continuavano ad adoperarsi per farlo.”(4) Io però aggiungo: non certo però i vertici del Pci, (tranne isolate eccezioni) neppure a livello “genovese locale”
Il libro di Paolo Piano ricostruisce la storia dei vari componenti del gruppo, avvalendosi della testimonianza diretta di molti dei protagonisti. Sono storie di proletari che progressivamente sviluppano la loro coscienza politica a contatto con le difficili condizioni materiali del dopoguerra. E ricostruisce anche le fasi del processo che durerà per circa quattro anni, e, anche se terminerà con condanne molto pesanti, vedrà il progressivo formarsi di un largo “credito politico” a favore del gruppo, che culminerà con la richiesta delle Brigate Rosse, in occasione del sequestro del giudice Mario Sossi, (che, tra le altre cose, era quello che fungeva da pubblico ministero durante il processo alla “22 Ottobre”) della liberazione di 8 membri del Gruppo XXII Ottobre. La Corte d’assise d’appello di Genova il 20 maggio 1974 diede parere favorevole alla libertà provvisoria. Ma il procuratore della Repubblica Francesco Coco si oppose al mantenimento dell’impegno (5).
Concludono il volume vari documenti tra cui quelli del soccorso rosso e i comunicati sul tema delle Br. Al volume è allegato un dvd con le interviste ad alcuni dei protagonisti. Un testo molto interessante per chiunque sia interessato alla storia di quegli anni.
(1)Donatella Alfonzo, Animali di periferia. Le origini del terrorismo tra Golpe e Resistenza tradita. La storia inedita della Banda XXII Ottobre, Castelvecchi, Roma, 2012.
(3) Paolo Piano “La <<banda 22 ottobre>> – Agli arbori della lotta armata in Italia”, ed. DeriveApprodi, II edizione riveduta e corretta, Roma 2008.
(4) Paolo Piano, op.cit. Pag.23
(5) fonte: Wikipedia
Che cos’è il carcere.
Pubblicato: novembre 26, 2020 Archiviato in: Carcere, Lotte, Repressione, Uncategorized | Tags: Carcere, Lotte Lascia un commento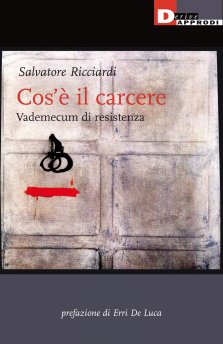
(La scomparsa del Salvatore Ricciardi nella primavera del 2020 è stata una perdita inestimabile per la coscienza morale e civile dell’Europa, il meno che si possa fare è mantenere vivo il dibattito sulle sue idee. La recensione che segue è stata già da me, pubblicata altrove, molto tempo fa, tuttavia mantiene tutta la sua attualità)
Ci sono molte esperienze, in vario grado “incomunicabili”, ossia esperienze che non possono essere efficacemente descritte a chi non le ha provate. L’esperienza della detenzione è tra queste. Salvatore Ricciardi, il quale è passato attraverso numerose esperienze di lotta per approdare alle Brigate Rosse e per sopravvivere a una lunghissima detenzione senza mai pentirsi nè dissociarsi, nella sua opera “Cos’è il carcere. Vademecum di resistenza”(1), prova a fornire una descrizione del carcere e contemporaneamente a dare a chi legge qualche idea su come sopravvivere psicologicamente a questa esperienza. Lo fa partendo dal suo “ritornare” al carcere da libero, chiedendosi esplicitamente quali siano le ragioni di questo ritorno. Domanda che troverà una sua compiuta risposta solo alla fine del libro, tra descrizioni di esperienze personali dell’autore, citazioni di opere di altri, e lettere dal carcere, di ieri e di oggi.
L’opera procede in modo assolutamente non lineare, alternando analisi, riflessioni, ricordi su temi e “su piani” diversi. Diversi temi ricorrono ciclicamente, vengono proposti per poi venire momentaneamente accantonati solo per ritornare “ampliando il discorso”. Si potrebbe, con una certa libertà descrittiva, paragonare la scrittura del Ricciardi in questo testo, alle opere liriche di Wagner, con leit-motiv che ritornano, ampliati, in chiavi diverse etc.
L’autore al principio analizza la sofferenza e la nozione di “accettabilità” di una sofferenza: “Quanto sia <<accettabile>> una sofferenza lo può decidere solo chi la subisce; ciascuno ha il suo limite che non è misurabile.” (2). Un nodo fondamentale è quello del concetto di tempo, il tempo ha una sua dimensione storica che deve far riflettere sulla transitorietà stessa del carcere, ma che per il soggetto che è detenuto è sperimentato come immobile, anche se si possono individuare dei momenti particolari come ad es. Il momento dell’arresto. Di qui anche il tema del ritorno al carcere: “Ci torni [in carcere] perchè quando ne hai fatta tanta di galera, e le sei stato ostile, tra te e lei si è aperto uno scontro mortale: o tu o lei. E’ una sfida che riguarda tutti i <<bravi ragazzi>> [termine del gergo carcerario che l’autore spiega come definente i detenuti solidali e ostili al carcere] e termina solo con la morte di una dei due.” (3). Un certo spazio è dedicato alle sensazioni fisiche, sapore, odori etc. Alla presenza degli altri, all’udito, alla cura di sè che più avanti nel libro viene quasi presentata come uno strumento di sopravvivenza. “Ma qui, in galera, ogni sensazione si tinge di colori forti. Gli stessi colori del ferro delle sbarre e della porta blindata”(4). In carcere, anche se vivi in mezzo agli altri, sei solo. Solo partendo da questo si può esaminare le relazioni tra detenuti.
“L’unica cura è ancorarsi alla concretezza dell’odio verso il carcere pensando, progettando e producendo rivolte o evasioni. E’ l’unico modo per restare sani, per evitare di essere stritolati dalla galera.”(5). Anche di qui l’esame del carcere procede su diversi piani, tra l’esame del suo ruolo sociale, i rapporti con il mondo “produttivo”, e di nuovo si affronta da più “prospettive” il problema del tempo e dei metodi per sopravvivere all’immobilità di questo in carcere: “Il tempo lo prende in consegna il carceriere”(6). E’ solo quando nel carcere scoppia una rivolta che il detenuto vive un tempo analogo a quello dei non-detenuti.
L’identità soggettiva è data (anche) dalle relazioni; Ricciardi illustra come la detenzione distrugga (almeno in parte) l’identità del soggetto precedente all’esperienza detentiva: “Prima di ogni altra condanna scatta il tempo della degradazione. Prima quella sociale, poi quella individuale” (7). L’autore ritorna poi al rapporto tra il detenuto e il proprio corpo, con uno sguardo quasi da antropologo parla delle auto-mutilazioni, dei tatuaggi, dell’urlo delle rivendicazioni corporee che in carcere diventano dominanti. E riflette (di nuovo) sulla sofferenza: “La sofferenza divide, non è vero che la sofferenza accomuna. Se soffri ti dà fastidio qualsiasi presenza, a meno che non sia totalmente dedicata ad accudirti e confortarti per lenire la tua sofferenza” (8).
Come contrastare l’annientamento? Il metodo implicitamente ed esplicitamente sostenuto dal Ricciardi è la rivolta, sia individuale sia soprattutto, collettiva: “Quando il carcerato cessa di essere ripiegato su sé stesso e, insieme ad altri, combatte la sofferenza che lo isola, inizia un percorso collettivo di contrasto all’annientamento” (9). Poi esistono metodi secondari e piccole regole.
Ci sono differenze tra carcere e carcere: “L’obbiettivo però è lo stesso: debilitare il corpo per sottomettere la volontà”(10). Questo viene perseguito in vari modi ma “anche Gramsci nelle sue lettere dal carcere annotava che il sistema carcerario <<manifesta la sua crudeltà non in efferatezze o sadismi, bensì nel tran-tran burocratico della detenzione, delle piccole vessazioni…>>” (11).
Un’altro elemento importante dell’esperienza detentiva è l’assenza di comunicazione da parte dei detenuti soprattutto verso l’esterno del carcere. E’ il carcere invece che si espande verso l’esterno, mentre una forma molto crudele di tortura carceraria è la “deprivazione sensoriale” impiegata nell’ex Germania Ovest.
Il carcere è uno strumento unicamente repressivo, mai però separato dal resto dello “sfruttamento produttivo”. Conclude il volume un dizionarietto dei termini del gergo carcerario, ma prima di questo, come conlusione, riporto le parole dell’autore che chiudono l’opera: “Ora ho capito il vero motivo di questo ritorno. Sono tornato in carcere per sentire di nuovo il sapore acre dell’odio verso la galera, per esserne di nuovo contagiato, non per portarlo via. [….] Sentirsi liberi di <<sciegliere>> di poter odiare il carcere, e la struttura sociale che lo produce e lo riproduce, è parte fondamentale della lotta per la libertà […..] L’odio verso il carcere ci aiuta a individuare i veri nemici e lottarci contro. La battaglia contro il carcere va intensificata con la convinzione che stavolta non siano i detenuti a soccombere ma il carcere. Che finisca! Che venga abolito![…]”(12)
(1) Salvatore Ricciardi, Cos’è il carcere. Vademecum di resistenza, ed. DeriveApprodi, Roma 2015
(2) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 13
(3) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 19
(4) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 28-29
(5) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 39
(6) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag.48
(7) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 54
(8) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 60
(9) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag.69
(10) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 76
(11) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 81
(12) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag.97
“Feedback”
Pubblicato: agosto 24, 2018 Archiviato in: Lotte | Tags: Lotte Lascia un commento(Già pubblicato “in vari luoghi” ma ancora attuale)
Della serie “cattivi consigli”, vorrei oggi che il lettore o la lettrice riflettessero su questa parola: feedback, in italiano: retroazione. Cosa significa questa parola per voi, per la vostra vita? E, in particolare, cosa significa questo concetto per I vostri “rapporti socio-economici”? Addirittura potrei parlare di “rapporti di classe”. Lo applicate? Davvero? Convinti? Sicuri? Torniamo indietro assieme di qualche passo. Dato che non vivo su qualche lontano pianeta, (contrariamente alla convinzione comune) sono circondato da persone che cercano lavoro, fanno colloqui, fanno vari corsi “di formazione”etc. Soprattutto in questi ultimi, (ma anche in molti altri ambiti…) viene posta la domanda “Come si affronta un colloquio di lavoro?”. Sgombriamo subito il campo da conclusioni affrettate: non esistono domande banali. Solo risposte banali. Oppure risposte “di scarsa qualità”. Se non erro, (non sono sicuro, comunque non ha importanza) è stato Carl Sagan, persona che ammiro moltissimo, a dire “la scienza serve per migliorare la qualità e la quantità di risposte che siamo in grado di dare”. E’ qui che entra in gioco il “ feedback” o retroazione. Nel rispondere alla domanda “Come si affronta un colloquio di lavoro?” interiorizzate, se posso usare questo termine, il concetto di “feedback”? Davvero? Convinti? Sicuri? E su cosa si basa questa sicurezza? Ora un ipotetico lettore o un’ipotetica lettrice “autocosciente” (non esistono) mi risponderebbe: “Mi sono messo/messa nei panni dell’interlocutore/interlocutrice, ho cercato di dare le risposte che al suo posto avrei voluto avere”. Oppure mi si potrebbe addirittura rispondere “Basandomi su una casistica X, ho dato quelle risposte che mi davano maggiori garanzie di successo”. Quindi siete convinti di applicare una sorta di “feedback”, date qualcosa per avere una risposta Y. Convinti? Nessuno “in sala” sostiene il contrario? Davvero? Chiaramente ho la certezza che rimarrete sulle vostre posizioni. Possiamo esaminiamo la questione da altri aspetti?No? Perchè? Qui ci troveremo di fronte a risposte diverse. Esaminarle tutte, ci porterebbe via più tempo di quello che la vostra pazienza consente. Ma sostanzialmente, la realtà è del tipo “così avete deciso e basta”. Cercherò brevemente di smontare un po’ la risposta: “è evidente che sia così”. Tutti concorderete che si tratta di una situazione “dialettica”, e sulla “scacchiera di Hegel” (vi piace questa immagine? Credo di non averla neppure coniata io), le mosse possibili sono limitate. Il punto è che voi stessi evitate persino di prendere in considerazione un certo numero di mosse possibili (rese possibili dalle “regole del gioco”). Voi avete già collettivamente bollato di “pessimismo” ad es. tutte quelle che potremmo definire le “strategie del giorno dopo”(ora vi spiego di cosa si tratta) malgrado che esse, storicamente, siano state (sembra) applicate con qualche risultato. E’ convinzione diffusa (c’è chi la mette in dubbio con argomenti storicamente fondati, ma come vedrete questo non ci interessa) che internet sia nato da una rete militare Usa. Ad un certo punto, il Pentagono avrebbe, secondo questa ipotesi, immaginato “Cosa succederebbe dopo, un attacco nucleare nemico coronato dal successo?” La risposta (secondo questa tesi) sarebbe stata “dobbiamo realizzare una rete di comando decentrata capace di resistergli”. Esaminiamo il “meccanismo di pensiero”. Ecco un esempio di “strategia del giorno dopo”, ipotizzare che la peggiore delle ipotesi realisticamente possibili sia già avvenuta, e agire di conseguenza. Ora i miei lettori e le mie lettrici esclameranno “Pessimismo!” se non “Paranoia!”…Ma la mia tesi è dimostrata: voi stessi esaminate un numero di “mosse possibili” più limitato di quante ne “permettano le regole del gioco”….Ed è anche una “illustrazione”, direi “da manuale” di come si possa strutturare una strategia sulla “retroazione”….Ora torniamo alla domanda iniziale: “Come si affronta un colloquio di lavoro?”, naturalmente non postulando che vi abbiano già scartati (ipotesi che renderebbe priva di senso la domanda), ma per esaminare le risposte che voi avete dato, ossia: “In modo che mi assumano a prescindere da ogni altra considerazione”. Davvero è “pessimistica” oppure “paranoica” quella che abbiamo definito la “strategia del giorno dopo”? Guardate che è molto più pessimistica e/o paranoica la tesi “l’interlocutore/interlocutrice non può trovare da sé ragioni sufficienti ad assumermi”. Ma torniamo al “feedback”. Ora, che tipo di feedback dà la vostra risposta? Esaminiamola un po’. Dato che tutti o quasi rispondano “In modo che mi assumano a prescindere da ogni altra considerazione”, l’interlocutore/interlocutrice è portato ad “alzare sempre più l’asta” delle sue richieste. No? E voi “a saltare sempre più alto”. Poi, facendo questa volta “l’ipotesi più favorevole”, se venite assunti, dovete in qualche modo adempiere a quanto avete promesso. E vi trovate di fronte a lavori sempre peggiori. Ecco come il meccanismo del “feedback” lavora contro di voi. Siete ancora convinti, di avere “interiorizzato” il concetto di “retroazione”?
Una sorta di necrologio….
Pubblicato: dicembre 1, 2017 Archiviato in: antipsichiatria, Lotte, Repressione | Tags: antipsichiatria, Lotte, Repressione Lascia un commento
“[…] la diagnosi psichiatrica è, ancor prima del manicomio, una via degradante senza ritorno. Infatti alcuni si suicidano, preferendo la morte, per non vivere come uomini di second’ordine. Però queste cose nessuno le dice. Se ne dicono altre. Si dice:”Dove li mettiamo i malati di mente perché non gravino sulle famiglie?”. Però alla domanda: “Ma cos’è questa malattia di mente?” lo specialista illuminato risponde con aria di competenza: “La malattia di mente è un mistero”. Non si dice che ognuno di noi può essere arbitrariamente giudicato malato di mente o sano di mente secondo le convenienze di chi comanda. E non si parla di una società umana violenta in cui i figli uccidono i genitori, i genitori maltrattano i bambini, le madri mandano i figli in carcere e tutta la vita familiare si svolge sul ricatto e sull’ipocrisia, ma soprattutto sulla mancanza di libertà. Così ci deve essere una disciplina che scheda le persone e le rinchiude col pretesto di aiutarle a vivere.” (1)
L’orrore e l’eccezionalità dei lager nazisti risiede anche (e, per chi scrive: soprattutto) nella divisione che veniva operata tra “umani” e “subumani”. Eccezionalità, perché sebbene la storia riporti altre campagne di genocidio, questa divisione, la pretesa di “scientificità” con cui era operata, e lo scrupolo con cui era condotta, ne facevano qualcosa di inedito. Se si vuol vedere qualcosa di simile, a parere di chi scrive, bisogna visitare (sempre che ve lo permettano!) il locale CSM (Centro Salute Mentale) o il locale SPDC ( Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura). Se la crudeltà è comunque minore, l’ipocrisia è certamente maggiore.
Varie fonti (2) riportano la notizia della morte, di Giorgio Antonucci, psicanalista, tra i principali esponenti dell’antipsichiatria in Italia. Sul piano pratico, dopo un periodo al fianco di Basaglia a Gorizia viene ricordato per il suo lavoro ad Imola, dove abolì i sistemi di contenzione fisica, fino allo “smantellamento” dei locali ospedali psichiatrici. Sul piano teorico, se da un lato proseguì quello che aveva già cominciato Basaglia, dall’altro si fece portavoce di una critica più radicale. In un intervista con Dacia Maraini (3) ad es. afferma: “E nel ‘68 che si è cominciato a discutere pubblicamente sull’esistenza o meno della malattia mentale. Io ho lavorato con Basaglia nel ‘69. Lui la malattia mentale la vede come una cosa dinamica che investe le persone meno resistenti. Per me la psichiatria è un’ideologia che nasconde i problemi reali delle persone ricoverate. Freud stesso diceva che occupandosi dei conflitti nevrotici aveva smesso di fare il medico e si era messo a fare il biografo”. Nella stessa intervista, come nelle sue opere, arriva a esporre una concezione che, sebbene possa ormai vantare anche molti altri sostenitori a livello internazionale, rappresenta senza dubbio un notevole passo in avanti rispetto alle ideologie oggi dominanti: “i malati mentali non esistono e la psichiatria va completamente eliminata.”
Ebbe vari riconoscimenti internazionali alla sua opera (4). Di lui rimane soprattutto “il sasso nello stagno” che ha gettato. Speriamo che i suoi successori sappiano continuare la portata rivoluzionaria della sua opera.
Qui parto con le “considerazioni personali” ovviamente: le mie, ossia del vostro affezionatissimo. Si può immaginare una psichiatria senza “costrizioni fisiche”. E sarebbe già un bel passo in avanti. Quantomeno si limiterebbero i morti per TSO (trattamento sanitario obbligatorio). Si può immaginare una psichiatria “con meno farmaci”. E sarebbe già un bel passo in avanti. Quantomeno si limiterebbero i danni fisici. Ma tutto ciò non diminirebbe minimamente l’orrore che è la psichiatria. Persino il dialogo può essere una forma di tortura, se è esercitato come una forma di potere e/o è un dialogo tra una persona che può e che sa e un’altra che invece…
Sul tema “sofferenza” non è certo una forma di rispetto etichettare certe sofferenze come “patologiche”; bisogna anche sottolineare il fatto che accettarle come “normali” è al contrario non solo molto più rispettoso, ma è anche più “costruttivo” nell’ottica di superale. Superamento che, è bene dirlo, può essere un opzione (e mai deve essere l’unica opzione) se e soltanto se c’è una consapevole scelta del soggetto in tal senso, scelta presa “nella sua solitudine”. Se invece è necessità imposta dall’esterno, si cade invariabilmente nel campo di orrori simil-nazisti.
Chi scrive è peraltro convinto che ad es. depressione, stati d’angoscia, allucinazioni, “dispercezioni” etc. (l’elenco può essere lunghissimo), vadano considerati come parte inseparabile della “normale” esperienza di vita dell’ individuo “umano”. Neppure l’ateo più incallito negerebbe a Padre Pio il diritto di avere le stigmate (quindi Padre Pio viene considerato come “umano”), a una buona fetta della popolazione viene invece negato il diritto alla classica “crisi di nervi” (quindi non vengano considerati “umani”) pena farmaci, reclusione, etc.
Due punti mi sembrano fondamentali ragionando su questi temi: il primo consiste nel dovere morale che ognuno di noi ha sempre, in ogni momento, di accettare, rispettare o quantomeno: non contrastare le azioni di un individuo (chiaramente: purchè e finchè resta “un individuo”, e non una società, un gruppo, una funzione sociale, etc.) che si pone contro una società, storicamente e fisicamente definita anche quando questo contrasto assume forme “perturbanti”, e soprattutto anche quando non comprendiamo né magari condividiamo le ragioni che lo muovono.
Il secondo: ricordiamoci sempre che purtroppo “Il fatto che il principio stesso di realtà sia relativo, che serva gli interessi della Chiesa e del capitale e che siano questi a definirlo, è escluso dalla discussione, in quanto questione politica che, dicono, non ha nulla a che fare con la scienza. Il fatto che anche la sua esclusione sia politica non viene colto affatto” (5). Mettere in discussione “il principio stesso di realtà” è un compito etico a cui non possiamo in nessun momento sottrarci. Se poi si vuol parlare di scienza, questa può iniziare solo con il continuo dubitare delle certezze acquisite, (quindi anche del principio stesso di realtà) come Galileo Galilei ha convincentemente dimostrato..
(1) Giorgio Antonucci, Critica al giudizio psichiatrico. Ed. Sensibili alle foglie, seconda ed. 2005 Roma ,pag.98
(2) ad es. http://www.leggilanotizia.it/notizia/13259/antonucci-lo-psichiatra-che-non-voleva-i-manicomi
(3) http://www.nopazzia.it/Antonucci/marainiantonucci.htm
(5) W Reich La rivoluzione sessuale. Massari editore, 1992, Bolsena (VT), pag. 74
La Repressione, tramite la legge, del Minorenne
Pubblicato: novembre 29, 2013 Archiviato in: Carcere, Lotte, Repressione | Tags: Carcere, Lotte, Repressione Lascia un commento(Questo articolo è stato pubblicato alcuni anni fa, sulla rivista “Lo Scomodo”. Dato che la suddetta rivista non esiste più, ma che l’articolo, benchè ormai “datato”, non ha perso completamente di attualità, ho creduto opportuno ripubblicarlo, con minime correzioni. Comunque, quando si parla di “comunità” ci sono alcune imprecisioni, che sono troppo pigro per correggere)
La struttura repressiva “par excellence” per i minorenni, non è il carcere bensì la famiglia. Non tratteremo questo aspetto della questione, anche se, come vedremo, ciò è ampiamente riconosciuto (“de jure”) dalla legge. Dove finisce l’azione della famiglia comincia quello della polizia. Qui inizia la nostra indagine. Cominciamo col dato empirico che il minorenne in stato di fermo o di arresto, specie se accusato di crimini “violenti”, ha probabilità molto maggiori dell’analogo maggiorenne di essere soggetto di abusi, specialmente se extracomunitario, clandestino, o apolide. I suoi diritti sono (“de facto”) comunque minori: se denuncia un abuso difficilmente è creduto, la sua testimonianza ha minore peso, si hanno meno riguardi etc. Tribunale e magistrato per i minori sono formalmente separati da quello ordinario. La discrezionalità del magistrato, per quanto riguarda i minorenni, è amplissima, è non è mai chiara la linea di confine tra abuso e azione legittima. Nello spirito delle attuali norme, il carcere per i minorenni dovrebbe essere una sorta di estrema risorsa repressiva a disposizione del magistrato. Prima di giungere a quello si tenta con l’affidamento alla famiglia, o ad una comunità, (utilizzate quindi come strumenti repressivi). Esiste anche l’istituzione della cosiddetta “messa in prova”, lasciandolo o ponendolo all’interno, ancora, della famiglia, o della comunità. Prima di ricorrere al carcere, o dopo una permanenza “x” in esso, si “prova” se il soggetto “delinqua” ancora o meno, impiegandolo in lavori che vengano definiti come “socialmente utili”. Anche il “metodo sperimentale” ha trovato la sua grottesca applicazione nel campo. La famiglia, definita secondo i canoni del cristianesimo (ideologia dominante), è riconosciuta dalla legge come la “prima istanza” repressiva. Non sempre però il magistrato ritiene la famiglia efficace oppure volenterosa. Si può trattare di un nucleo familiare i cui membri siano disoccupati-nullatenenti, pregiudicati, detenuti, tossicodipendenti, clandestini, residenti all’estero o addirittura irreperibili (caso non così infrequente, specie tra i cosiddetti “nomadi”). In questi casi, per “qualsiasi sciocchezza” si può giungere in carcere (ad es. con l’uso della cosiddetta “custodia cautelare”) Ricordiamo che il magistrato in questione dispone di ampia discrezionalità, e l’affidamento alla famiglia di origine può venire rifiutato per un’ ampia gamma di ragioni, non sempre intellegibili. Diremo semplicemente che se la famiglia è di basso livello socio-economico, oppure di origini extracomunitarie, (o ancora: se i suoi membri sono ritenuti inaffidabili/irreperibili) è probabile che il magistrato non la ritenga idonea. Il secondo gradino è la comunità. Le comunità esistenti spaziano da strutture semplicemente costituite da un prete cattolico che aggiunga qualche letto alla sua sacrestia, fino a realtà gestite da associazioni e molto strutturate. Alcune di queste sembrano essere veri lager, in altre “l’ospite” viene (quasi) lasciato totalmente a se stesso. Non viene fatta alcuna differenza formale tra queste, ed è solo il caso (ma anche: la disponibilità di posti-letto nell’immediato) che determina la destinazione ad una o ad un’altra comunità. Non sempre il magistrato reputa il soggetto idoneo alla comunità. A volte (e questo rientra nella discrezionalità del suddetto magistrato) un soggetto x viene fatto stare y tempo in carcere e poi improvvisamente (buona condotta o meno) trasferito in una comunità. Enumeriamo alcune particolarità del carcere minorile, dando per scontato che il lettore o la lettrice siano al corrente delle pratiche generalmente in uso nelle strutture detentive, quali ad es. il mantenimento “sotto farmaci” dei soggetti più irrequieti. Le regole e la vita dentro il carcere minorile sono generalmente solo un pò migliori di quelle del carcere per “adulti”. Si hanno cortili più spaziosi, regolamenti più blandi, carcerieri senza uniforme. Un discorso a parte andrebbe fatto per quanto riguarda i farmaci, qui impiegati quasi esclusivamente in funzione repressiva. Un minore che entri in carcere viene (dopo formalità che il lettore può immaginarsi da solo) formalmente affidato ad un educatore. Ci sono educatori che “educano” altri che si considerano guardiani, altri ancora che non fanno alcunchè. Grosso modo possiamo dire che viene svolto l’obbligo scolastico, poi si fanno attività più o meno “formative”. Possiamo osservare che la vita dentro il carcere minorile è più “attiva” di quella dentro il carcere per adulti. Non necessariamente questo è un fattore positivo. Se il dettato costituzionale secondo cui la pena deve “rieducare” è di fatto disatteso per i maggiorenni, per quanto riguarda i minorenni, questo è strumentalmente utilizzato per giustificare qualsivoglia genere di oppressione, se non di abuso. Si giunge all’estremo di vedere inflitte punizioni corporali, perlopiù da parte degli agenti di custodia, con la scusante di voler “educare”. Ma anche senza voler giungere a questo, possiamo empiricamente osservare come “educare” sia, utilizzato come scusante per costringere, comandare, o quantomeno spegnere ogni barlume di individualità…Gli educatori sono sottoposti ad un educatore-capo, ed il magistrato visita saltuariamente la struttura (o almeno può visitare saltuariamente la struttura). I trasferimenti da carcere a carcere, come quelli da carcere a comunità, avvengono a discrezione del magistrato, tranne i casi di conclamata “incompatibilità ambientale” (generalmente tentativi di evasione). Empiricamente osserviamo che sono frequenti, e, di nuovo, spesso privi di ogni ragione intellegibile. Sembra che i legislatori abbiano voluto “traslare” l’autorità (in origine?) paterna della “patria podestà” sulla figura del magistrato. Le analogie sono inquietanti, e non gettano una buona luce né sulla famiglia né sui legislatori. Ultimamente sta prendendo piede l’abitudine di colpire qualsiasi comportamento “non appropriato” del minore (uso di alcolici, scritte sui muri, etc.), tramite sanzioni economiche, che chiaramente chiamano in causa la famiglia del soggetto. Questo ci riporta al punto di partenza ossia all’ uso repressivo della struttura familiare.