“DIzionARIO ANTIPSICHIATRICO”
Pubblicato: marzo 14, 2023 Archiviato in: antipsichiatria, Repressione | Tags: antipsichiatria, Repressione Lascia un commento
“Le vie della psichiatria sono infinite. Si può essere accusati e rinchiusi in manicomio criminale, come è successo ad un esponente dei Verdi, anche con diagnosi di altruismo morboso” (1). Nonostante il “superamento” dei manicomi attraverso la famosa legge Basaglia, e nonostante la recente evoluzione che ha portato alla chiusura dei famigerati OPG (Ospedali Psichiatrico Giudiziari), la cronaca continua a riportare casi di morti per TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio), “ricoveri forzati”, e simili….
Dove comincia la polizia finisce la scienza, e se per Freud come per Jung “è inutile cercare di guarire a tutti i costi” (2), dal lato poliziesco invece l’uso della psichiatria è noto fin dagli ultimi tempi dell’URSS, quando qualunque dissidente era automaticamente definito “malato di mente”. Qualcuno/a ricorderà persino il giudizio su simili pratiche da parte di Primo Levi “[…] comporta un uso abietto della scienza, ed una prostituzione imperdonabile da parte dei medici che si prestano così servilmente ad assecondare i voleri dell’autorità”(3). Sarebbe ipocrita applicare “due pesi e due misure” all’esperienza italiana e a quella dell’URSS del dopo Breznev…
Giuseppe Bucalo, nella sua opera “DizionARIO ANTIPSICHIATRICO” edito dalle edizioni Sicilia Punto L, demolisce molte delle convinzioni comuni sul tema della malattia mentale. Già nell’introduzione, ci porta a riflettere su “a chi serva” considerare certi comportamenti come “sintomi”, e sull’arbitrarietà del nostro giudizio circa la “follia” o la “normalità”.
Il primo capitolo si intitola “Che cos’è la malattia mentale?”. L’autore, ci dimostra che non esiste nessun criterio veramente scientifico. “Se ci trovassimo davvero in campo medico, ciò costituirebbe un paradosso” (4). Tutto ciò che è incomprensibile ( soprattutto se, per giunta, dà noia agli altri), è passibile di venire diagnosticato in campo psichiatrico. Peggio ancora, vista dalla giusta prospettiva, qualunque cosa può essere incomprensibile. “Teoricamente, e praticamente, noi potremmo ottenere una diagnosi psichiatrica per ognuno dei nostri familiari e amici”(5). Neppure gli psichiatri più esperti riescono a separare “il grano dal loglio”. L’autore riferisce di un esperimento in cui persone “sane” si sono (consapevolmente) presentate in strutture psichiatriche, fingendo “sintomi” per vedere se i medici riuscivano a separarli dai “malati”. E, nella totalità dei casi, i medici non sono riusciti a capire chi era “sano”. “Nel loro rapporto, gli sperimentatori citano il fatto paradossale che gli unici a nutrire dubbi sulla loro identità, erano stati altri ricoverati”(6). L’esperimento venne, in seguito, tentato anche “al contrario”. Venne annunciato ai responsabili di strutture psichiatriche che si sarebbero presentrati dei “falsi pazienti”. In realtà nessun “falso paziente” venne inviato. Ma i direttori sanitari delle strutture in questione rifiutarono ugualmente un gran numero di ricoveri, credendo che si trattasse di sperimentatori. Quindi….. mancano totalmente i famosi “criteri verificabili”che definiscono la scienza.
Il secondo capitolo è “Che cos’è l’antipsichiatria?”. Date le premesse, questa può essere solo un modo di porsi verso il comportamento altrui nel quale l’incomprensibile e quello che ci sembra incongruente non è un sintomo patologico e, per giunta “L’idea che senza il nostro aiuto la stragrande maggioranza dei pazienti psichiatrici si suiciderebbe, ucciderebbe qualcuno o vivrebbe sotto i ponti è del tutto infondata” (7).
Quest’ultimo concetto viene sviluppato nel capitolo successivo “Paradossi psichiatrici”; le cure moderne non potendo quindi avere serietà scientifica sono solo metodi di controllo. Nè è ravvisabile un qualche serio progresso nella loro evoluzione: “Il fatto di trattare meglio le persone non significa trattarle da persone”(8).
In “Ipotesi di sopravvivenza” l’autore dà qualche esempio, tratto dalle sue esperienze di medico, di quale può essere l’atteggiamento “antipsichiatrico”. Giuseppe Bucalo passa quindi a discutere dei pregiudizi più comuni su cosa sia l’antipsichiatria: essa non fornisce nessuna sociogenesi alternativa della cosiddetta “malattia mentale”, perché la scienza non è in grado di stabilire cosa la “malattia mentale” sia, e neppure se essa davvero esista; quindi l’uso degli psicofarmaci può giustificarsi solo al livello dell’uso di altri “generi voluttuari”(alcool, tabacco, caffè etc.); non si può parlare di abbandono quando invece si cerca di capire e di dialogare al posto di cercare il controllo e il contenimento. Chiude il volume un “dizionario minimo” con citazioni di vari studiosi.
Arrivati a questo punto, il lettore/lettrice permetteranno all’autore di questa recensione qualche considerazione a carattere generale.
Parlare di “sofferenza psichica” è parlare di qualcosa di estremamente comune a tutta l’umanità. E’ difficile confutare una vasta gamma di pensatori -dal Leopardi al Sofocle, da Baudelaire allo Shopenhauer, che hanno mostrato l’universalità della sofferenza, dicendo che “il sano non soffre”. Ogni vivente, soffre orribilmente in ogni attimo della sua esistenza (e, secondo molti: persino dopo morto, opinione con la quale concordo). Nessun tipo di cura “verrà a capo di ciò”. Al di là di questo, bisogna ricordarsi che se una società è democratica in quanto capace di accettare il dissenso al suo interno, allora non può discriminare quale dissenso sia “da sani” e quale “da trattamento obbligatorio”. Giordano Bruno, per fare “un nome a caso”, è stato bruciato vivo perché dissentiva sul modo di vedere la realtà della maggioranza delle persone del suo tempo. Allora veniva considerato “eretico” ma la sua concezione della pruralità dei mondi sarà certamente parsa anche “folle”. Adesso non bruciamo più gli eretici, li mettiamo in TSO in quanto “pazzi”. E’ cambiata solo la pena, non la condanna. E le giustificazioni che diamo a noi stessi sono pericolosamente simili a quelle che davano a se stessi gli inquisitori….
(1) Giuseppe Bucalo, DizionARIO ANTIPSICHIATRICO, Sicilia punto L edizioni, Ragusa 1997, pag 10
(2)Carl Gustav Jung, Introduzione alla psicologia analitica, Bollati Boringhieri editore Torino 2000, pag.149
(3)Primo Levi, Appendice a “Se questo è un uomo” Einaudi scuola Torino 1976 pag. 246
(4) Giuseppe Bucalo, op. cit.pag.36
(5)Giuseppe Bucalo, op.cit. pag.41
(6) Giuseppe Bucalo, op.cit. pag.42
(7) Giuseppe Bucalo, op.cit. pag. 59-60
(8) Giuseppe Bucalo, op. cit.pag.74
L’autunno tedesco
Pubblicato: settembre 6, 2022 Archiviato in: letteratura, Lotte | Tags: letteratura, Lotte Lascia un commento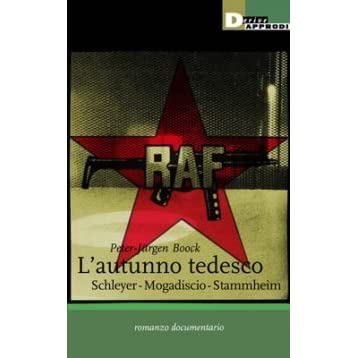
(ripubblicato qui, con varie aggiunte)
Quante volte, solo a distanza di anni, ci rendiamo conto dell’effettivo significato di una conversazione, di un discorso? E quante volte gli stessi protagonisti non si rendono conto di quello che stanno dicendo? E quante volte solo una terza persona può capire “il nocciolo del problema”? Persino molto al di là delle intenzioni dello stesso autore, quest’ultima domanda salta particolarmente in mente leggendo “L’autunno tedesco” di Peter-Jürgen Boock, “romanzo documentario” (in Italia edito dalla DeriveApprodi, Aprile 2003) che narra, nella prospettiva soggettiva dell’autore-protagonista, una pagina di storia tedesca ancora discussa. Il titolo si rifà al famoso documentario “Germania in autunno”. L’autore, dopo un’adolescenza problematica in cui sperimenta l’oppressione della famiglia e la violenza dello stato, viene a contatto con gli elementi che fonderanno la RAF (Rote Armee Fraktion, -frazione dell’Armata Rossa- gruppo rivoluzionario tedesco ). Al momento in cui questi ultimi verranno incarcerati, decide di darsi da fare per liberarli. Siamo nell’estate del ’76. Insieme ad altri, sequestra il presidente della confindustria tedesca, (Hanns-Martin Shleyer, già gerarca nazista, poi alfiere del capitalismo “mannaro” della Germania Occidentale del secondo dopoguerra) per usarlo come “merce di scambio” per ottenere la loro liberazione. Fin dal momento dell’agguato, il gruppo si trova ad essere succube degli eventi. Sulle soglie della consapevolezza di essere guidati dagli avvenimenti che si susseguono, piuttosto che esserne gli artefici (del resto, commento io, come tutti in qualsiasi situazione), i protagonisti si barcamenano alla meno peggio, nell’estema stanchezza, tra traslochi con l’ostaggio e trattative con le autorità. Risalta impevista l’umanità (non vogliamo chiamarla ordinarietà?) di tutti i coinvolti, da Shleyer, che si preoccupa della sorte che è toccata al suo autista (e questa è la prima domanda che pone al gruppo), ai “rapitori” , che si preoccupano continuamente dell’impressione che stanno dando all’”ostaggio” (fino al punto che una di loro verrà sorpresa a giocarci a monopoli). E di questo l’autore è assolutamente consapevole…Ma attraverso questa “banalità”, la figura di Shleyer (chiamato familiarmente “Spindy” dal gruppo ), malgrado i sensi di colpa ammessi dell’autore, filtra una luce diversa, potremmo dire “in filigrana”….Oggi, possiamo forse (?) vedere più chiaramente l’assenza di positività (ma anche, di necessità) dello sviluppo economico e industriale di cui “Spindy” tesse – senza venire realmente contraddetto- le lodi al gruppo….I cui componenti, pur intuendo confusamente la continuità – di cui “Spindy” è esemplare- tra passato nazista e presente (1977) “industriale”, non riescono proprio a trovare “il bandolo della matassa” e rimangono frustrati nelle loro intenzioni polemiche di fronte all’uomo in carne ed ossa; che risponde cordialmente alle domande, si mostra umanamente interessato agli operai, e non risponde alle provocazioni…Anche se lo stesso uomo nota con una certa sfrontatezza che “nel 1944 il paese toccò il suo massimo indice di produttività” (pag. 93) oppure rinfaccia agli interlocutori: “senza quella generazione, che non è responsabile solo dei crimini del nazismo, ma anche della ricostruzione di un paese distrutto, voi non ve la sareste passata tanto bene” (pag.77)….I “sequestratori” non riescono a contrapporgli che argomenti morali, di cui sono i primi a confessare la relatività…Dimenticando così i motivi concreti che li avevano portati fino a quel gesto. La contrapposizione tra di loro diviene quindi una contrapposizione di anime spinte dal destino. E qui apro una digressione, “con il senno di poi”. Se i paesi del “blocco orientale”, analogamente agli stessi Stati Uniti, potevano (e in qualche misura …) trovare una qualche giustificazione etica e morale al progresso industriale nell’esplorazione dello spazio, e -nel caso statunitense- nell’apertura in generale di “nuove frontiere”, lo sviluppo industriale della RFG (Repubblica Federale di Germania), la cosiddetta “Germania ovest”, appare -di nuovo “con il senno di poi” particolarmente povero di qualsivoglia giustificazione nelle sue azioni e omissioni. Questo non era un problema esclusivo della RFG , ma qui si parla di Germania. Persino la famosa contrapposizione alla RDT è difficile da concepire se non in un contesto di accesa “paranoia reciproca”, paranoia certo auto- indotta e funzionale al mantenimento di determinati equilibri, ma che noi “posteri” stentiamo davvero a credere “ragione sufficiente” di fronte a “bestialità” come l’esistenza -e persino lo sviluppo!- di “cose” come la Borsa di Francoforte. E che certo non ci sembra sufficiente a confronto con le sofferenze (e la schiavitù salariata) di milioni di persone (se esaminiamo solo l’area tedesco-occidentale) che ha portato. Ma, al di là delle “scuse morali” ( o della loro assenza), il richiamo costante alla concretezza dei fatti è la lezione che Marx non è riuscito a “passare” a molti suoi epigoni. Che così fanno “misera scena” di fronte ai più spudorati sostenitori “del vivere all’inferno perché così ci piace”. Fine digressione. La vicenda narrata da Peter-Jürgen Boock finirà in tragedia, malgrado tutti. Proprio nel “malgrado tutti” stà la grandezza del libro. L’autore “viene trasferito” in Iraq dove assiste impotente al tentativo di sbloccare la situazione tramite il dirottamento (in “coproduzione” con i palestinesi) di un aereo tedesco prima nello Yemen, poi a Mogadiscio (che finirà con la morte dei dirottatori), all’uccisione di “Spindy” (quando ormai i sequestratori avevano rinunciato a “processarlo” e ne riconoscevano una sorta di influenza morale sul gruppo), all’inesplicabile (suicidio o omicidio?) morte dei compagni in carcere che volevano liberare (che sembra “presa di peso” da qualche scena di Eschilo o di Sofocle), fino alla dispersione dei superstiti…Senza nominare i classici greci, Peter-Jürgen Boock, ne testimonia la perenne attualità.
“Sorry we missed you”
Pubblicato: aprile 1, 2022 Archiviato in: Uncategorized Lascia un commento
(ripubblicazione con minime modifiche, data la continua attualità del tema)
L’attuale tendenza a mascherare lo sfruttamento del lavoro tramite un’apparente auto-imprenditoria, e soprattutto il mondo delle consegne a domicilio, ultima frontiera della “modernità” capitalistica, sono al centro dell’ultimo lavoro di Ken Loach, “Sorry we missed you”.
Il protagonista Ricky decide di diventare un corriere, teoricamente “freelance”, ma in pratica completamente subordinato ad una ditta di consegne a domicilio di articoli vari. Però, per far quello deve comprare un furgone e, per acquistarlo convince la moglie a vendere la sua auto (e di conseguenza lei dovrà prendere ogni giorno l’autobus nei suoi spostamenti come badante). Questo lavoro si rivela devastante per l’intero nucleo familiare, non solo per i ritmi disumani (oltre al resto, gli autisti sono anche costretti a urinare in una bottiglia per rispettare i tempi) ma anche perché il protagonista per portarlo avanti è costretto a trascurare la famiglia, e soprattutto i problemi adolescenziali del figlio maggiore che finisce anche per commettere un piccolo furto. Anche la moglie ha i suoi problemi con il suo lavoro – che comunque le permette di sviluppare un profondo rapporto con le persone che assiste – e la mancanza dell’auto si fà sentire. Dopo varie vicessitudini, il protagonista viene assalito sul lavoro, pestato e derubato della merce che doveva consegnare. Ma il suo capo chiarisce che, a causa di questo furto e dei danni conseguenti, gli verrà chiesto di pagare di tasca propria una cifra altissima per risarcire l’attrezzatura rotta e le cose che gli sono state rubate. Il film si chiude con il protagonista che in un estremo tentativo di “sbarcare il lunario” si mette alla guida del furgone ancora con un occhio bendato e il resto del corpo pesantemente segnato….non cè una fine speranzosa ma la cruda realtà.
Questo film illustra in maniera magistrale come il riscatto di un membro della classe operaia non possa passare per la ricerca di un chimerico “arricchirsi”. Questo è un punto estremamente importante per noi che ci troviamo a vivere in un momento in cui l’auto-sfruttamento indotto dalle illusioni del sistema capitalista è diventato una delle principali catene da infrangere per buona parte della classe operaia. Il mondo del lavoro specialmente quello “di consegne veloci” è dipinto con grande realismo e con grande maestria, così come emerge magistralmente la psicologia dei personaggi e l’attuale contesto storico. Qualche perplessità può emergere di fronte a una certa idealizzazione della famiglia, idealizzazione del resto piuttosto diffusa in un momento come questo nel quale essa appare l’unica certezza in un mondo dove le cose non sono quelle che appaiono.
Bisogna che il lavoratore lotti, come diceva il Ricciardi, anche contro quella parte di sé che arricchisce il padrone. E senza confidare su istituzioni come la famiglia che nonostante le (eventuali) buone intenzioni dei propri membri finiscono inevitabilmente per generare e tramandare violenza e oppressione.
E concludo con una frase di Ken Loach “Questo capitalismo è intollerabile”
La psichiatria, e il cosiddetto “bisognoso di cure”…
Pubblicato: novembre 3, 2021 Archiviato in: antipsichiatria, Lotte, Repressione | Tags: antipsichiatria Lascia un commento“Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza!” I. Kant
Per la chiesa cattolica il peccatore non è libero nelle sue scelte. Infatti egli è “cattivo” ossia captivus diaboli : ‘prigioniero del diavolo’ . Analogamente per la psichiatria il cosiddetto “malato” non è libero : per ragioni irrazionali e francamente incomprensibili egli/ella non sarebbe un soggetto dotato di libero arbitrio, o quantomeno: lo sarebbe solo in quanto e per quanto si riconosce come malato, desidera “curarsi”, vuole raggiungere la “serenità” etc.. Questa distinzione tra “psichicamente sani” e “psichicamente malati” al netto della sua natura discriminatrice potrebbe -per assurdo- anche e persino avere un (suo) senso se l’esperimento Rosenhan (1) non avesse dimostrato che neppure uno psichiatra è davvero in grado di distinguere tra “le pecore e le capre”.
Manca infatti nella realtà (2) uno di questi stati: ossia la supposta (uso il termine in voga qualche anno fa) “malattia mentale”. Solo nella condizione nota come “coma”, un essere umano è realmente “incapace di intendere e di volere”, tutti gli altri : “vogliono”, e qualcosa persino “intendono” (anche se normalmente “comprendono” molto poco), persino i neonati, che sanno benissimo cosa vogliono, e riescono persino a comprendere alcune delle cose fondamentali come il bisogno di cibo e il modo di richiamare l’attenzione altrui.
Ancora più arbitrari sono i termini che si sono affermati in seguito. Attualmente si cerca di parlare ad es. di “sofferenza psichica” invece che di “malattia mentale”. Oppure ancor più arbitrariamente e genericamente si parla di “persone bisognose di cura”. Lo schiavo, ovviamente un soggetto che per definizione non è autonomo, oltre ad dover essere efficiente nel suo ruolo subalterno, deve anche essere sorridente per non turbare la digestione ai padroni. Inoltre, c’è chi sa meglio del soggetto stesso quale sia il suo bene e come raggiungerlo, altrimenti non vivremo tutt* in una società capitalistica e oppressiva. Ma la genericità di questi nuovi termini (sul tema “sofferenza” tornerò in seguito), fa da contrappeso a dei modelli ideali di comportamento e di relazioni sempre più stringenti (DSM 4 e 5) e omnicomprensivi, tanto che ormai qualsiasi comportamento potrebbe essere definito come “patologico”. Persino tra gli psichiatri (3) esiste chi mette in dubbio la necessità di una tale stringente e omnicomprensiva categorizzazione, segno che essa sta diventando non più funzionale alla formazione e al mantenimento -in ruolo ovviamente subordinato – degli schiavi del Capitale.
Ovviamente come ogni teoria utilizzata a fini repressivi, la psichiatria dispone dei mezzi ideologici e pratici per auto – convalidarsi. E quindi cerca “in primis” di concretizzare l‘assenza di libero arbitrio che essa vorrebbe che esistesse “di natura” nelle persone ad essa soggette. Di qui la “necessità” delle “cure”. Di qui una moltitudine di mezzi coercitivi che culminano nel Tso, ma che partono in realtà dalla società in cui la psichiatria opera (pressioni familiari, economiche, lavorative…). Questi mezzi coercitivi, nella società sono “generici”, con la psichiatria diventano molto specifici. Il soggetto non deve e quindi non può “fare da sé”. Il serpente si morde la coda. Gli strumenti veri e propri della psichiatria si caratterizzano infatti per cercare di togliere specificatamente appunto la capacità (e/o la volontà) del soggetto di autodeterminarsi; capacità e volontà che secondo la psichiatria sono già escluse ( e spesso: a priori ) dall’ esistere nel soggetto. Questi strumenti partono dai farmaci, generalmente portatori di dipendenza fisica, per arrivare a “terapie” basate sul “dialogo” (che come vedremo possono -in questi casi- anch’esse venire considerate come una vera e propria tortura, e che comunque hanno lo stesso scopo dei farmaci, ossia di far mutare qualcosa nel/al soggetto, sotto un qualche “indirizzamento” dall’ esterno).
Il metodo per eccellenza -per contrastare l’autodeterminazione del singolo- rimane però quello stesso di propagandare un modello di comportamento e di relazioni, arbitrariamente definito come “salute mentale”, che non necessariamente rispecchia la volontà (o la natura) del singolo stesso. A questo modello tutt* devono conformarsi, pena l’essere considerati “umani di serie B”, bisognosi di cure, incapaci di autodeterminarsi, e possibilmente da sorvegliare, se non “da instradare” quantomeno con “il dialogo”, se non con farmaci, quando non con la contenzione fisica o l’elettroshock (metodi entrambi tutt’ora usati in Italia).
Il modello ideale di comportamento e di relazioni a cui tutt* devono conformarsi viene giustificato “a posteriori”, in tanti modi. Adesso è di moda la giustificazione bio-chimica. Questa, come ogni giustificazione a posteriori (infatti le diagnosi psichiatriche non partono dalla constatazione della presenza di determinati squilibri bio-chimici nel soggetto), è persino accusabile di essere “in mala fede”. Il problema però non è che un determinato modello di comportamento e di relazioni venga giustificato con la bio-chimica piuttosto che con altro, il problema è che di nuovo, porre un qualsivoglia modello come quello a cui tutt* devono conformarsi, volenti o meno, “costi quel che costi”, rende (“sinergicamente” ad altri fattori) la psichiatria “mero strumento repressivo”, nei fatti, a prescindere dalle intenzioni anche lodevoli di taluni psichiatri.
Di sfuggita devo comunque notare che la giustificazione bio-chimica delle “terapie” (notare le virgolette) psichiatriche rischia però di peggiorare le valenze normativo-repressive delle terapie in campo neurologico (si pensi ad es. ai malati di Alzheimer). Di questo non mi occuperò nel presente scritto, rimandando il tema ad una trattazione “a sè”.
Sulla base della mia, certo parziale e relativa esperienza, metterò con la massima sistematicità a me possibile “nero su bianco” alcune considerazioni che ritengo (a torto o a ragione) di una certa necessità sui temi della psichiatria e della cosiddetta “salute mentale” in generale. Lo scopo principale di questa esposizione (spero) ragionata è offrire “un framework” di strumenti teorici e qualche considerazione pratica “farina del mio sacco”a chi si opponga all’ azione repressiva.
A)Considerazioni preliminari:
Esistono delle comuni “pietre d’inciampo” filosofiche, errori comuni che rendono più facile l’opera repressiva non solo della psichiatria, ma di tutto “un apparato” che si autodefinisce come “assistenziale”. Cercherò di essere sintetico…
1)Le scelte che facciamo
La “pietra d’angolo” del rispetto umano è rendersi conto che qualsiasi scelta (conscia o inconscia) fatta da qualunque persona è “valida” e “degna di rispetto” quanto le scelte che abbiamo fatto te e io. L’assassino che uccide per il piacere di farlo, e il santo cattolico che vive nella miseria, ha le stigmate sulle mani e soffre per i peccati del mondo, insieme alla rockstar che grida a tutte le ore e al monaco ortodosso che ha fatto voto di silenzio e contempla immobile tutte le cose, hanno fatto tutt* delle scelte che dobbiamo rispettare e accettare, anche se non le condividiamo, quanto quelle dell’ impiegato dell’ufficio accanto. La maggior parte delle scelte fatte da chiunque, viene presa non in maniera cosciente (si legga ad es. il famoso libro “I persuasori occulti” di Vance Pakard, se se ne vuole una dimostrazione “spicciola”), il grado di consapevolezza con cui viene fatta qualunque scelta è sempre talmente basso da non consentire un giudizio “di selezione” su di queste basato “sulla maggiore o minore consapevolezza” di una scelta, anche se in casi abbastanza particolari (l’adesione delle masse al nazismo o al fascismo) la mancanza di consapevolezza dell’individuo aggrava ( e non alleggerisce) la responsabilità del singolo individuo. Se ci si rende conto del nostro (di noi “osservatori”) grado di soggettività e se non si hanno pretese di “oggettività”, si può parlare di “condivisibilità”, si può anche parlare di “comprensibilità” etc. Esiste un giudizio “politico” che rimane fondamentalmente “nostro” e che anche per questo non vogliamo “esportare” dentro coloro che non la pensano come noi, esiste un giudizio morale basato su convinzioni che sono “par excellence” persino incomunicabili con l’altr*, possiamo persino chiederci quali siano le ripercussioni sociali di queste scelte, ma rimane (e deve essere continuamente ribadito) il punto da cui sono partito: l’assassino, l’impiegato di banca, il monaco, Sid Vicious, Maurizio Costanzo e il tossicomane all’ angolo della strada hanno fatto delle scelte “equivalenti” (tra loro e alle nostre) da rispettare e accettare. Stà a loro (e non a noi) decidere se e eventualmente: quando, “riconsiderare” queste scelte. Riconoscere l’altr* come umano è accettare ( e non voler cambiare) le sue scelte anche se l’ altr* corre nud* tutto il giorno 365 giorni l’anno, urlando per la strada e per giunta ci dà anche fastidio. Jung scriveva che ognuno deve arare il suo campo con il suo proprio aratro. Il mio può essere migliore, ma purtroppo non glielo posso prestare (4). Questa non è indifferenza. Se l’altr* soffre, indifferenza è non soffrire con lui/lei. Ma credere di poter risolvere i suoi problemi, meglio di come sta già facendo lui/lei è “hybris”. Se e quando interveniamo, facciamolo almeno con la consapevolezza di agire per il nostro e non per l’altrui interesse.
Neppure l’ateo più incallito negherebbe a Padre Pio il diritto di avere le stigmate (quindi Padre Pio viene considerato come “umano” e capace -in fondo- di autodeterminarsi), né l’ateo rispettoso cercherebbe di evitare a un qualsiasi santo cristiano -cattolico di avere le sue terrificanti visioni dell’inferno. A una buona fetta della popolazione viene invece negato il diritto alla classica “crisi di nervi” (quindi non vengano considerati “pienamente umani” ossia capaci di autodeterminazione) pena farmaci, reclusione, etc.
Qui ovviamente ho parlato sottintendendo che il soggetto in questione sia maggiorenne. Se ci si vuole prendersi cura di un minorenne, togliere tutto ciò che nella società di noi adulti “lo indirizza” affinché ogni sua scelta diventi un domani davvero “farina del suo sacco”, è molto più efficace e incisivo (oltreché costruttivo) rispetto a tante cosiddette “terapie centrate sul soggetto”. Comunque anche il discorso “minorenni” richiederebbe una trattazione a sé, e visto che per ora parlerò di altro, anche più avanti, sottintenderò che quanto scrivo è inteso come riferito a dei soggetti maggiorenni.
E’ diffusa, purtroppo non solo in ambito psichiatrico, la “moda” di etichettare alcuni comportamenti sgraditi allo psichiatra o all’assistente sociale di turno (o ad altri “facenti funzione”) come “infantili”. A ciò, già rispondeva “ante litteram” l’inno napoleonico “Le chant du depart” che affermava che “i repubblicani sono degli uomini, gli schiavi sono dei bambini”.
2)La condizione umana
Affrontiamo sinteticamente i temi della “serenità” e della “non -sofferenza”.
Moltissimi pensatori da Pascal a Nietzsche fino a Leopardi hanno ritenuto che la condizione umana sia naturalmente “portata” alla sofferenza. E’ difficile confutare tutti questi con l’esistenza di un “modello” gabellato come “salute mentale” secondo cui : “il sano non soffre”. Ovviamente sarebbe parimenti sbagliato dire che “il sano è colui che soffre”. Tutt’al più potremmo lasciare aperta la possibilità teorica che esistano persone che non soffrano, o che comunque non siano proprio completamente travolte da questa sofferenza, se ciò è conforme al loro volere (conscio e inconscio). Se una persona ha scelto sia consciamente che inconsciamente “la serenità” potrebbe (forse) non soffrire orribilmente in ogni attimo della sua vita, ma allora: nessuno meglio di lui/lei saprebbe dirgli come fare per farlo, e ogni interferenza esterna non potrebbe che rendergli le cose più difficili.
Se le circostanze esterne rendono il soggetto “schiavo salariato” o peggio, il minimo sindacale che il soggetto dovrebbe chiedere è quello di essere nevrastenico. Anche qui, un intervento sul soggetto produrrà tutt’al più un tossicodipendente da farmaci. In casi come questo, qualsiasi intervento dall’esterno che non stravolga le circostanze economico-sociali in cui il soggetto vive, è puro “addolcire la pillola” (e qui per “pillola”intendo il lavoro salariato). Ci si può anche chiedere quale sia il grado di “autenticità” della “serenità” così ottenuta.
Scegliere la “serenità” è comunque una scelta che il soggetto può consciamente anche non fare. Molti preferiscono apertamente essere “un mare in tempesta” piuttosto che uno stagno. E come ogni scelta, non rispettarla è proprio della “repressione” non della medicina.
E’ pura ideologia, lontana da ogni valutazione dei fatti empirici anche il dire che un soggetto è o non è travolto dalla sua sofferenza al punto di non essere più “funzionale”, perchè ci potrebbero essere casi in cui la molla di un comportamento appparentemente “normale” consiste esclusivamente in un’assoluta disperazione, senza di cui il soggetto non si alzerebbe da letto, nè si vestirebbe o altro. Henry David Thoreau, sarebbe probabilmente d’accordo nel constatare ciò. In generale, di nuovo, mi si obbietterà che in taluni casi la “sofferenza psichica” del soggetto impedisce al soggetto stesso di espletare varie “funzionalità”. Al di là di quanto già detto, mi sembra davvero banale rispondere (e per questo non mi soffermerò molto su di questo) che questa “funzionalità” oggi finisce sempre e inevitabilmente per essere una funzionalità calibrata sui desideri dei “padroni del vapore” e che quindi non si è in grado di definirla in termini davvero obbiettivi. Nella pratica anche un discorso sulla “funzionalità” o sulla “disfunzionalità” (anche nei contesti in cui ad esempio si parla di genitori “disfunzionali”, di “abilità relazionali” eccetera), finisce “per portare acqua” al mulino del Capitale. Purtroppo questo risultato inficia ogni pretesa di “obbiettività”. Bisogna quantomeno provare ad essere obbiettivi, (la “sospensione del giudizio” viene praticata solo in teoria e per giunta proprio da chi poi formula diagnosi psichiatriche che sono “un giudizio”) riconoscendo se un tipo di valutazione può essere obbiettiva e quindi può essere fatta e se invece questo tipo di valutazione non può essere fatta e quindi ci si deve astenere dall’usarla. Tornerò comunque sul tema “efficienza e autosufficienza”.
Le vigenti leggi non mi permettono di esprimere tutto ciò che penso sul suicidio (si veda la vicenda editoriale del libro “Il suicidio modo d’uso” di Claude Guillon-Yves Le Bonniec, censurato persino in Francia e sequestrato in Italia) tuttavia il fatto che sia stato realizzato da tanti uomini e donne illustri, in una pluralità di circostanze, basta a smentire chi vorrebbe che il metterlo in pratica sia sinonimo di qualche alterazione del pensiero.
3)Il principio di realtà
Il problema “che cos’è reale e cosa no”, si pone, ed è un problema molto pratico anche in tutti i casi in cui opera “un qualunque apparato” che si autodefinisce come “assistenziale”. Non volendo esaminare qui ad esempio il problema dei rapporti tra ideologia e concezione della realtà, esamininerò la questione da un punto di vista “pragmatico”. Parlare di “deliri”, “derealizzazioni” e quant’ altro, in relazione a ciò che sente o che vede un’altra persona, è sicuro segno che “non si hanno buone intenzioni”. Questo vale anche se si considera un esperienza “x” di un’altra persona “non oggettiva”.
“Il fatto che il principio stesso di realtà sia relativo, che serva gli interessi della Chiesa e del capitale e che siano questi a definirlo, è escluso dalla discussione, in quanto questione politica che, dicono, non ha nulla a che fare con la scienza. Il fatto che anche la sua esclusione sia politica non viene colto affatto” (5) .
Timothy Leary parlava di “realtà consensuale” ( 6) , il dato oggetto non è pesante x, dotato mettiamo di densità y, composto dalla sostanza z, etc. ma siamo noi che gli attribuiamo consensualmente questi attributi. Questo è “un discorso” che può essere accettabile, se tutte le percezioni su cui si basa “il consenso” vengano ugualmente considerate come valide (anche quelle dissenzienti), e se il risultato finale è “mera convenzione”. Ora, dobbiamo però stare attenti perché “soggettivare” ogni questione è un metodo, usato “in zona psichiatria” per tacere la verità. Di nuovo: voglio essere pragmatico. Sarebbe “meglio e più pratico” ipotizzare che non esista una realtà oggettiva, fattuale, ma un numero “x” di realtà oggettive, fattuali e sperimentalmente dimostrabili (“galileiane”) coesistenti nel medesimo spazio-tempo. All’ interno di alcune di esse vigerebbe ad es. il principio di non contraddizione, ma è chiaro come, nell’insieme, questo principio non potrebbe valere. A considerazioni per certi versi simili arriva per esempio la fisica moderna, e ciò “è molto più costruttivo” dell’ultima variante dell’etichetta con la scritta “delirio”, o alla “soggettivizzazione” di tipo psicanalitico. Vedremo quando si parlerà specificamente di psicosi e di schizofrenia cosa questo comporti per queste “etichette”. Tuttavia ciò dovrebbe essere “tenuto ben presente” ben oltre il campo propriamente psichiatrico, ma ogni volta che le nostre valutazioni su un oggetto o sulla natura (magari umana o demoniaca o altro) di un soggetto (o di noi stessi) divergano da quelle di qualcun’altro.
Qui accennerò solo che discorso “scivola facilmente” sul religioso. Chi mi parla ad esempio: di “crisi psicotiche” dovrebbe innanzitutto dirmi in che cosa una “crisi psicotica” si differenzia da un autentica esperienza religiosa, spesso terrificante e comunque in grado di “sopraffare” il soggetto. Libertà religiosa vuol dire innanzitutto non essere giudicati e/o detenuti a causa dell’incontro con “il piano di sopra”, indipendentemente da come lo si concepisca (spesso l’altro/altra è visto come “l’estraneo per eccellenza”, quindi potenzialmente divino – si legga l’Odissea di Omero al proposito – e sempre e comunque: come portatore di “pathos” interpretabile benissimo e legittimamente come pericoloso). Sul tema comunque ritornerò…
4) Il mito dell’autonomia e dell’autosufficienza, il “bisognoso di cure”.
Spesso una reale o presunta non autosufficienza di un soggetto viene presa a pretesto per negargli la possibilità di fare determinate scelte. Tutto ciò si basa sull’assunto mitologico secondo cui al contrario esistano persone autosufficienti “per loro natura”, e anche su altri ragionamenti parimenti illogici.
Oggi anno 2021 una persona analfabeta o anche solo “analfabeta digitale” non è assolutamente in grado di “vivere autonomamente” nella nostra “collettività”. Nell’anno 1000 tutto ciò era la norma. Qualche annetto prima, Carlo Magno rimase analfabeta, nonostante disponesse dei migliori insegnanti dell’epoca. Fortunatamente in quel periodo non c’era nessuno che gli diagnosticasse qualcosa di “moderno”. Già questo dovrebbe dirci che non esistono persone di per sé autosufficienti ma è la società in cui una persona vive a determinare (e, come dicono gli anglosassoni, in modo “random”) se un soggetto è autosufficiente o meno, a prescindere dalle caratteristiche del soggetto in questione.
Purtroppo assistiamo a un meccanismo pseudo-logico di pensiero per cui se un soggetto ha bisogno di essere assistito (e anche lì…andrebbe visto il se e il perché, ma soprattutto se lui/lei vuole o meno esserlo), l’assisterlo significherebbe far il possibile per impedirgli tutto ciò che secondo noi potrebbe nuocere a lui/lei o a altri. Se una persona ha bisogno di assistenza e la chiede, questa deve fermarsi al momento che lui/lei smette di volerla, e limitarsi a ciò che il soggetto vuole (oltre ad altre considerazioni che vedremo più avanti). Se non la chiede ma mettiamo: è in pericolo di vita, ovviamente questa assistenza può essergli data senza che il soggetto “espliciti cosa vuole” a condizione che il soccorritore sia davvero disposto a mettere in discussione il suo comportamento ( ad esempio chiedendosi: era davvero necessario? Ho rispettato quella che sarebbe stata la sua volontà se avesse avuto il tempo di esprimerla?). Il fatto però che un buon samaritano assista una persona “x”, non dà al buon samaritano in questione nessuna “autorità morale” sul soggetto soccorso, né soprattutto (e qui spesso ….) implica che il buon samaritano sappia meglio del suo assistito cosa sia opportuno e cosa sia masochista fare o non fare.
“Peggio ancora”, il dire che una persona è “bisognosa di cure” è esso stesso un negare la libertà di scelta del soggetto, anteponendo a questa libertà una nostra valutazione. Questa mia affermazione, sembra un sofismo, ma è un tema che ha pesanti ripercussioni pratiche nella vita di tutti i giorni. Una persona può volere qualche tipo di “cura” (dubito che esista qualcuno che le voglia assolutamente tutte, dall’elettroshock alla colonoscopia, passando per i bagni termali e l’antica pratica del tatuaggio terapeutico), oppure no, indipendentemente dalla condizione in cui si trova. Se non vuole essere curato oppure se vorrebbe essere curato solo in modo “x”, oppure solo da “y” o anche solo nel modo “z” , e noi diciamo invece genericamente che è “bisognoso di cure” neghiamo la libertà di scelta di lui/lei. Quello che è davvero importante è se il soggetto vuole “essere curato ” (oppure no), in che modo e da chi (e per quanto tempo).
B)Adesso parliamo di psichiatria e di coloro che ne sono soggetti
Bisognerà cominciare con il dire che anche astraendo dalla diffusa minaccia (che può essere implicita o esplicita) del TSO, “in zona psichiatria” almeno ¾ dei pazienti, se non di più “entrano e rimangono” solo a causa (quando non appunto di violenze “in atto”), di minacce esplicite o implicite (magari persino da parte della propria famiglia o dal posto di lavoro), che possono essere di vario genere: anche il dire: fai come ti dico io o starai male è comunque una minaccia; un medico “degno di questo nome” direbbe: fai come dice la scienza medica e spero che tu guarisca in ogni caso.
Non essendoci in psichiatria “una malattia”, come abbiamo visto all’inizio è difficile sperare in una guarigione. Anche fuori dal reparto ospedaliero i soggetti marchiati con una diagnosi psichiatrica vengono vessati in un numero troppo grande di modi diversi perché io qui mi metta a farne una casistica: si và dalle visite domiciliare “coatte”, fino al ritiro della patente. Esistono anche “case famiglia” per “disabili psichici” e strutture para-ospedaliere “per tutti i gusti”. Impossibile non citare “en passant” il lavoro in pratica “coatto”, a cui talun* vengono sottoposti, lavoro che può prendere il nome di “terapia occupazionale” e che si risolve, quando non nell’obbligatorio trastullarsi in cose inutili, nello svolgere dei compiti senza essere pagati quanto altr* e/o senza i diritti che hanno gli altr*, ma soprattutto: senza essere liber* di fare altre cose.
Un dato di fatto che “salta all’occhio”, entrando “in area psichiatria” è il livello di “non-verità” negli enunciati di psichiatri e persino del personale infermieristico e tecnico. Si capisce facilmente da dove, nella pratica, vengano fuori le disquisizioni di Basaglia (7) sui rapporti tra realtà e ideologia, tema su cui non mi soffermerò, benché effettivamente coerente con il nostro argomento.
Se una persona “x” pronuncia un enunciato su cui lui stesso non sarebbe d’accordo, possiamo dire che “mente”. Ugualmente possiamo dire che “mente” se nasconde o omette di dire qualcosa che sarebbe tenuto a dire. Ora, anche fuori dagli spazi in cui si esercita la psichiatria … ”Le menzogne sono oltremodo diffuse”. Tuttavia solo gli psichiatri hanno il cosiddetto “privilegio terapeutico”, se non sbaglio persino riconosciuto “ex lege” di mentire ai pazienti sui farmaci. E, se “le balle” finissero qui, sarebbe “culpa levis”. Il grave è appunto il confronto con l’esterno. Fuori dagli spazi in cui si esercita la psichiatria, la “non-verità” è a) è normalmente intenzionale, b) viene esercitata con un “range” ristretto di metodi e c) è generalmente funzionale a qualche scopo razionale.
“In area psichiatria”, dato che viene postulato un difetto nel pensiero dei pazienti, è facile che qualche “balla” venga a loro detta “fuori da ogni intenzione”. I metodi per non dire la verità sono del resto tantissimi. Si evita di affermare, o di confermare che ad esempio “x = 2”. Si “soggettivizza” la questione. Si esamina il modo in cui la questione è posta, per non entrare nel merito della stessa. Si evita una disamina degli argomenti che depongano contro la tesi che si sta sostenendo. Eccetera.
Quando, come spesso avviene, “x è ritenuto essere uguale a” , la “non-verità” più comune consiste nel non entrare nella disamina sul perché x sia ritenuto uguale ad a, In effetti si cade nella disonestà intellettuale dicendo che “x = a”. Il “minimo sindacale” è lasciare “aperta” ogni questione di cui non si hanno “prove matematiche”, non tacendo affatto la propria opinione in proposito (altro modo usato a volte per mentire ) ma appunto: sottolineando che ciò “non è vangelo” (altrimenti non è un opinione ma una menzogna).
L’unico scopo razionale effettivamente esistente per molte “balle” (il fatto che pronunciarle o tacere la verità sia considerato terapeutico non è uno scopo razionale: è uno scopo ideologico) è la mancanza di tempo. Tuttavia, fuori dai reparti psichiatrici, se un tema richiederebbe dieci ore per venire decentemente trattato e non si ha questo tempo, si impiegano formule del tipo “scusandomi per la mancanza di tempo che mi impedisce di trattare decentemente la questione, sono costretto a banalizzarla dicendo che….”. Quindi la mancanza di tempo viene, in questo caso affermata come parte integrante della “verità del momento”. Simili formule sono pressoché sconosciute nella pratica psichiatrica…
E tutto ciò “non è ancora il peggio”. Mettere in discussione una diagnosi, soprattutto se è una diagnosi di schizofrenia, o di psicosi o simili, cosa che dovrebbe essere considerata come “il minimo sindacale” richiesto dal paziente a uno psichiatra “amante della verità” è invece visto come prova stessa della patologia del soggetto. O quantomeno come il segno del suo aggravarsi. Quindi la schizofrenia è davvero un dogma religioso, di cui non è dato dubitare, come ha notato giustamente qualcun’altro ( 8). Inutile aggiungere che, da parte dello psichiatra, un simile atteggiamento è “disonestà intellettuale” per eccellenza.
Difficile “fare una colpa” agli infermieri per le menzogne che essi dicono, perché in genere essi mentono su indicazione di altri, e sono soggetti a ogni ricatto. Degna di menzione, per la sua diffusione e per le sue ripercussioni, è però la non-verità, spesso da essi enunciata persino in buona fede e senza particolari “pressioni dall’alto” secondo cui le visite ai pazienti in TSO sono condizionate all’approvazione del medico o sono soggette ad altre condizioni. La legge afferma invece che devono poter avvenire “punto e basta”. Chiaramente ci sono dei limiti dettati dal “buon senso” (chiaramente non ci possono essere visite la notte etc.), e persino accettare (o meno) delle limitazioni arbitrarie a ciò può essere “consigliabile”. Tuttavia, di nuovo “ex lege”, queste visite devono poter avvenire. Anche la comunicazione per telefono o tramite internet, tra il paziente in TSO e le persone che rimangono fuori, deve poter avvenire per legge “senza alcun vincolo”.
Come dicevo all’inizio, gli strumenti veri e propri della psichiatria si caratterizzano per cercare di togliere specificatamente appunto la capacità (o la volontà) del soggetto di autodeterminarsi; un tassello importante è cercare di convincere il soggetto, in modi più o meno razionali a (dover) cambiare qualcosa nel suo modo di interagire con gli altri o con sé stesso, o comunque di essere “bisognoso di cure”.
Anche se si trattasse solo di “dialogo” (qui faccio un breve accenno, ma tornerò sull’argomento), offrire delle soluzioni “dall’alto” ovvero far intendere che queste non possano essere trovate dal soggetto in modo indipendente è sottrarre al soggetto qualcosa della sua capacità/libertà di autodeterminazione.
La cosiddetta “psicosi”, le cosiddette “crisi psicotiche”, la schizofrenia
Come ho accennato all’inizio ampliare il campo del “patologico” fino ad includere assolutamente tutto è una delle tendenze della psichiatria contemporanea. Se tutto è “sofferenza psichica” e “patologia” allora nulla è patologico e la psichiatria non ha ragione di esistere, se non come esercizio teorico. Ma questo non è coerente con tutto l’armamentario di ricoveri coatti e di farmaci imposti per forza che la psichiatria “si tira dietro”.
Esiste il famoso metodo della dimostrazione per assurdo. Se non si vuole che la psichiatria non abbia alcuna ragione di esistere bisognerà tracciare un confine, ad esempio: tra legittima esperienza religiosa e esperienza patologica. Ovviamente la legittima esperienza religiosa, mettiamo : di Padre Pio con le sue stigmate, di Santa Ildegarda con le sue visioni, dei colloqui con il diavolo, degli incontri con Dei travestiti da mortali dell’Odissea, dell’eterna relazione conflittuale con elfi e folletti e quant’altro, deve essere salvaguardata dall’essere soggetta all’ armamentario di cui sopra. Dato che la libertà religiosa è un diritto riconosciuto dalla nostra costituzione, perché esso venga salvaguardato il confine deve essere quantomeno “netto e quello”. Nella pratica psichiatrica invece se c’è un confine, non è “molto ben definito”.
Quindi, di nuovo (dato che questa domanda farebbe evolvere la stessa psichiatria) in che cosa una “crisi psicotica” si differenzia (e deve differenziarsi, pena l’assurdità e l’illegalità di ogni diagnosi di psicosi) da un autentica esperienza religiosa, spesso terrificante e comunque in grado di “sopraffare” il soggetto?
Molti “santi” riconosciuti formalmente tali dalla chiesa cattolica esprimevano concetti religiosi in aperto contrasto con le credenze dei loro contemporanei. Si hanno santi che non venivano capiti da nessuno, santi con una relazione difficile con il prossimo, incluso in certi casi le stesse gerarchie ecclesiastiche, i loro familiari e via discorrendo. Quindi i rapporti che la persona ha con il resto dell’umanità e con il mondo in generale “non fanno testo”. Neppure i rapporti del soggetto con sé stesso “fanno testo” perché ci sono stati “santi” con tanto di “riconoscimento ufficiale” che apertamente odiavano sé stessi.
Né lo “stile di vita”può darci qualche indicazione. Ci sono stati santi eremiti e anacoreti, e anche santi “stiliti” che oggigiorno rischierebbero di passare per esibizionisti vista l’impossibilità fisica di espletare i propri bisogni dall’alto di una colonna senza essere visti.
Ma il cristianesimo non è più la “religione ufficiale”. Ci può essere una religione come il buddismo senza un dio, oppure come i culti ufologici. Non è necessario quindi che il soggetto riconosca la natura “soprannaturale” dell’esperienza.
Punto focale della riforma luterana fu proprio l’affermare la libertà interiore del soggetto di cercarsi un suo proprio personale rapporto con ciò che non è razionale. Però, se “ribaltiamo la prospettiva”, parlare di “psicosi” e “schizofrenia”, sottintendendo “la necessità” di farmaci e magari di ricovero coatto, non è un metodo che possa dirsi accettabile per porsi di fronte a un soggetto che non comprendiamo. Se chi parla in questi termini poi non accetta che il soggetto stesso “metta in discussione” la cosiddetta “diagnosi”, siamo nel campo del dogma religioso, e non è accettabile che questo venga imposto dall’esterno a persone non consensienti.
Coloro che invece si ritengono malati, e che desiderano essere “aiutati”
Già in “medicina generale” si deve affrontare il problema di coloro che vogliono i più dolorosi interventi chirurgici senza che ci sia un’effettiva necessità. L’esempio più banale, del resto molto più comune di quello che normalmente si crede, è quello degli esami medici, a volte fisicamente spiacevoli, pensiamo ad esempio ad una colonoscopia, ma che vengono “chiesti a gran voce” da alcuni pazienti, anche quando la scienza medica non li crede necessari…
Come ho già detto “in zona psichiatria” almeno ¾ dei pazienti “entrano e rimangono” solo a causa, di minacce esplicite o implicite. Bisogna anche aggiungere che gli appartenenti all’infima minoranza di pazienti volontari reali, e non costretti né dalla famiglia, né dal datore di lavoro, né dall’assistente sociale etc. spesso non hanno idea del fatto che “da quella porta si entra facilmente ma normalmente non se ne esce”.
Però esistono persone che si ritengano “malati” e “bisognosi di cure psichiatriche/psicologiche/etc.”, ed è possibile persino trovare tra di loro esempi di persone consapevoli di ciò che tutto questo comporta. Ovviamente è assolutamente lecito che un soggetto si auto-consideri tale…Esaminiamo le cose “da un’altra prospettiva” . Quando una persona considera il pensiero o il modo di relazionarsi con il mondo di un altra persona come “difettoso” al punto di credere di sapere meglio del soggetto stesso di cosa lui/lei abbia bisogno, entriamo quantomeno in un terreno “molto scivoloso”. Indipendentemente dal fatto che il soggetto sia il primo a considerarsi “difettoso” quando sei tu a considerarlo tale, hai “l’onere della prova” di dimostrare te stesso “migliore”, prova che spesso persino i migliori psichiatri -quasi sempre- falliscono.
Comunque il considerare sé stessi “bisognosi di cura” è una libera scelta, e non un qualcosa che “è dato di fatto”. Il modo migliore di aiutare costoro, sarebbe tuttalpiù quello di convincerli a fare autonomamente una scelta diversa. Obbiettivo questo, che quasi mai è coscientemente perseguito “in zona psichiatria”. Ancora meglio sarebbe lasciare che “il paziente” pervenga autonomamente a una diversa conclusione…
Considerazioni sull’uso dei farmaci
Una sofferenza psichica atroce e intollerabile è, a mio avviso, una costante dell’esperienza di vita di qualsiasi essere umano. Questa può avere vari “sbocchi” e manifestarsi in modi abissalmente diversi. La soluzione può essere cercata in tanti campi : attraverso la filosofia, l’arte, magari persino : la lotta politica e “di classe”. Cercarla attraverso i farmaci (qualsiasi essi siano) non può che dar luogo a una tossicodipendenza. Se questa è la libera e consapevole scelta del soggetto, non c’è nulla di male. Perché sia appunto una scelta libera, dato che ci sono tante cose che vengono socialmente accettate molto meno di una tossicodipendenza, specie da farmaci, e dato che questa tossicodipendenza potrebbe essere “spinta” dal contesto sociale che vede in essa un alternativa a comportamenti meno accettati, bisogna che “la collettività” si renda finalmente conto che qualsiasi tipo di comportamento, e di interazione con sé stessi e con gli altri, ha lo stesso valore (anche se non magari la stessa “condivisibilita’”) al netto di ogni giudizio morale / religioso . Quindi qualsiasi farmaco sarà “legittimo” dopo la fine della “legittimità” del giudizio psichiatrico nella coscienza popolare (oltre che dopo la fine della sua validità giuridica che predispone all’obbligatorietà dei farmaci psichiatrici).
Potremmo fare anche varie considerazioni sul concetto di “consenso informato”. Se và oltre il “consenso informato”, un medico non è più un medico, ma diventa qualcos’alto. Se un paziente “non è ritenuto capace” di consenso, il medico che lo considera tale dovrebbe proprio per ciò limitare il suo intervento allo stretto necessario per mantenerlo in vita. A parte questo caso estremo, “consenso” significa poter dire “si o no” senza che si adottino misure legali. “Informato” significa aver elencato comunque tutte le possibili alternative e tutti i possibili “effetti collaterali”.
Il dialogo come esercizio del potere
Non c’è bisogno di andare “in zona psichiatria” per sperimentare che anche il dialogo, “il dialogo e basta” può essere una forma di tortura. Per questo è sufficiente frequentare “I tutori della legge”. Se il dialogo viene esercitato tra una persona “che può e che sa” e un’altra che invece “non sa e non può” (es. Il dialogo tra un poliziotto e un normale cittadino), è facile che si arrivi ad una forma di tortura, tanto più se il soggetto arriva al momento del dialogo “provato” da vicessitudini varie, e particolarmente se questo dialogo non si può evitare, pena che succeda qualcosa di peggio. In “area psichiatria” è difficile che il dialogo abbia altri intenti che quelli di “convincere” il soggetto che c’è qualcosa che deve essere cambiato nel suo modo di pensare o di relazionarsi con il mondo, quindi l’intento è analogo a quello di ogni altro metodo usato. Il dialogo è “una buona cosa” se e quando rispetta invece 3 condizioni:
a) parità tra gli interlocutori, anche in termini di conoscenze e possibilità d’azione.
b) nessuno degli interlocutori vuole che l’altro “cambi” qualcosa di sè stesso, nè che “riveli” qualcosa di sè contro la sua volontà.
c) c’è un reale consenso (ossia una volontà dei soggetti non una necessità delle circostanze) tra gli interlocutori sui tempi e sulle forme in cui il dialogo avviene.
Al di fuori di queste tre condizioni, il dialogo è una forma di potere che viene esercitata.
C) Come può combattere la psichiatria chi ne è “paziente”
In tutti i campi e in tutte le circostanze della vita, è più facile “urlare e disperarsi” che lottare davvero per i propri diritti. A questa regola generale non sono esenti coloro che purtroppo si trovano a dover fare affrontare in prima persona la psichiatria. Bisogna ricordarsi sempre che “il vittimismo non serve a niente” (9 ) nè servono pianti e lamenti.
Premesso che è impossibile imbarcarsi in una enumerazione delle possibili circostanze e delle cose che è opportuno fare non fare, data la pervasività della psichiatria nella società contemporanea, cercherò di “mettere nero su bianco” alcune regole generali e alcune “situazioni ricorrenti”.
Qualunque disgrazia, anche l’essere soggetti al “giudizio psichiatrico” può (e forse dovrebbe) diventare occasione di lotta politica e persino di “arricchimento culturale”. Trovare “un perché” alle cose che ci succedono è sempre importante, non “il perché” che ci viene proposto, ma un “perché” che sia realmente la nostra spiegazione, che ha valore proprio in quanto (e fin quanto) è la nostra “versione dei fatti”e non quella di qualche altr*. I libri di autori come Giorgio Antonucci o Giuseppe Bucalo possono essere un punto da cui partire se non si ha nessuna idea su come farlo.
Statisticamente inutile è cercare di convincere uno psichiatra che ha torto, se chi cerca di convincerlo è un suo paziente. Si veda di nuovo l’esperimento Rosenhan di cui parlavamo all’inizio. Alcuni ritengano che il “paziente” si tuteli meglio mentendo (“riconosco di essere malato”, “desidero curarmi”), e io non dubito che in certi casi, questa possa essere “la scelta migliore”, e quella che può dare risultati nell’ordine del “breve e medio termine” (giorni, settimane e mesi) , tuttavia confesso qualche dubbio sul se possa essere una strategia vincente “nel lungo termine” (anni), e se appunto possa essere inclusa in un discorso di “lotta politica”.
Contro un Tso si può fare ricorso, e chiunque può fare ricorso contro un Tso di chiunque altro. Ricorsi da parte di “non ricoverati”, scritti argomentando in base alla legge il caso specifico, ripetuti ad ogni rinnovo (ogni 7 giorni), “formalmente ineccepibili” e, di nuovo: con argomentazioni giuridiche sensate e specifiche (non “copia-incolla” per intendersi), “fanno un loro effetto”. Ci vuole tempo, costanza nel presentare i ricorsi, ci vuole che essi vengano fatti da un congruo numero di persone, possibilmente del comune stesso in cui avvenga il Tso. Al proposito si ricordi che il fatto che il soggetto assuma i farmaci in forma orale è già “sbandierabile” come prova giuridica del fatto che il soggetto stia accettando le terapie, dato che il rifiuto delle stesse è tra le condizioni “ex lege” perchè un Tso venga effettuato e si rinnovi. Anche questo è eventualmente comunque da argomentare entrando nel caso specifico.
[aggiungo dopo aver ricevuto costruttive critiche: il “senso” dei ricorsi non è tanto quello che un ricorso potrebbe essere accolto. Il “senso” è che lo psichiatra che agisce nel “buio” del reparto-SPDC-etc, agisce in un modo. Lo psichiatra che invece si trova di fronte ad una situazione in cui ad ogni rinnovo di un TSO questo TSO viene -> dall’esterno della struttura in cui opera, puntualmente contestato da -mettiamo- una decina di punti di vista diversi, che entrano nello specifico di quel TSO, presentando ricorsi con argomenti giuridicamente validi, agisce in modo diverso. Soprattutto: con il passare delle settimane. ]
Anche da parte di un ricoverato in Tso è possibile firmare una diffida contro una determinata terapia, tuttavia io sono scettico sulla reale incisività di simili diffide.
Il coinvolgimento di un avvocato (ci sono avvocati che fanno volontariato in varie associazioni, è comunque possibile in vari modi “averne uno gratis”), dovrebbe essere considerato dal soggetto come “cosa banale” invece spesso non lo è. Ovviamente ci sono anche avvocati “pessimi”, ma …
Esistono vari collettivi, associazioni, la cui intenzione è quella di opporsi all’azione della psichiatria, io consiglio di provarli tutti fino a trovare quello che va bene per le esigenze del singolo. Contattarli “non in sequenza”, prima uno e poi un altro, ma “in contemporanea”, non solo nel caso di qualche emergenza, ma anche come “misura preventiva” così da avere più suggerimenti su come uscire da una data situazione, cosicché tu che sei soggetto alla psichiatria vedrai da solo che le possibili strade sono molte, devi essere te a scegliere quale percorrere, e non a lasciare che gli altri scelgano per te.
Da un ricovero “volontario” (spesso frutto di minacce o “pressioni varie”) è possibile (ed è la via più facile) uscirne approfittando di una “libera uscita” specialmente se questa avviene accompagnati da qualcun’altro (di esterno) che è d’accordo “sull’andarsene”. Teoricamente è possibile anche “firmare e uscire”, e questo sarebbe formalmente anche meglio, tuttavia nella pratica potrebbe essere davvero un’ impresa. Di nuovo : “ogni caso è una storia a sé”, ed è il soggetto a dover valutare cosa fare e come farlo. Anche se si decide di “firmare e uscire” (e di nuovo : formalmente sarebbe meglio), “i testimoni aiutano”, soprattutto se “scelti con criterio”.
Cambiare comune, ossia andare ad abitare altrove, quantomeno oltre i limiti della Asl “di riferimento” può essere la scelta migliore in molti casi. Soprattutto: una volta usciti dal reparto dell’ospedale. “Nessun luogo vale un assedio”, in molti casi pochi km di distanza “fanno la differenza”, e comunque, nei casi peggiori, (quando si parla di “pericolosità sociale” associata a una diagnosi “in area psicosi”) io non esito a suggerire se le circostanze lo permettono, e appunto : “come extrema ratio”, persino l’espatrio. Con pazienza e organizzazione si possono fare cose che sembrano impossibili…San Marino, la Svizzera o un paese Ue “non sono la prima scelta” da fare in questi casi, ma potrebbero comunque ( a seconda dei casi) essere “una scelta da considerare” se l’alternativa è subire “tutto un assedio”, ovviamente dopo l’aver esaurito le altre possibilità, primo la consultazione di associazioni e collettivi, secondo la consultazione di avvocati, etc.
La soluzione migliore, e “buona per tutti i casi” anche se molto generica, rimane quella di Kant: “Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza!”. Della tua. Non di ciò che dicono gli altri.
Note:
(1) https://it.wikipedia.org/wiki/Esperimento_Rosenhan
(2) per essere esatti dovrei parlare di realtà al plurale, come vedremo in seguito.
(3) Oltre ai dubbi già espressi da Basaglia, recentemente abbiamo le critiche al DSM espresse dal Pietro Cipriano. Si veda P.Cipriano “Il manicomio chimico” ed Eléuthera, Milano 2015 , e P.Cipriano “La società dei devianti” ed Eléuthera, Milano 2016
(4) Carl Gustav Jung, Introduzione alla psicologia analitica, Universale Bollati Boringhieri editore, Torino 2000, pag. 149
(5) W Reich La rivoluzione sessuale. Massari editore, 1992, Bolsena (VT), pag. 74
(6) si veda Leary Timothy “High Priest”, ed. New American Library, New York 1968
(7) si vedano i saggi “Condotte perturbate” e “Crimini di pace” in Basaglia Franco, L’Utopia della realtà, Enaudi 2005
(8)Szasz T. Schizofrenia: simbolo sacro della psichiatria, Roma: Armando, 1984
(9) Abatangelo Pasquale, Correvo pensando ad Anna, Edizioni DEA, Firenze 2017 pag. 261
La “banda 22 ottobre”, di Paolo Piano
Pubblicato: Maggio 21, 2021 Archiviato in: Lotte | Tags: Lotte Lascia un commento
Rientra nei “fatti storici” che uno dei primi “nuclei” a passare alla lotta armata, fù il cosiddetto “Gruppo XXII Ottobre” attivo a Genova (e dintorni) tra il 1969 e il 1971. Sulle vicende che li videro protagonisti sono stati scritti -o almeno: sono a conoscenza di chi scrive- due libri. Il primo è “Animali di periferia” di Donatella Alfonzo (1), che sebbene si avvalga anche delle testimonianze di alcuni dei protagonisti, ha visto “il ripudio” ufficiale da parte di uno degli intervistati (2). L’altro è quello di Paolo Piano “La <<banda 22 ottobre>> – Agli arbori della lotta armata in Italia” edito dalla casa editrice DeriveApprodi (3).
Il libro parte dall’episodio che segnò in pratica la fine della vita operativa del gruppo, ossia la rapina, o per essere più esatti dovremmo dire “lo scippo a mano armata” a scopo di finanziamento ai danni dell’istituto autonomo case popolari a Genova del 26 marzo 1971. Rapina finita male, con la morte di un portavalori. Le immagini della rapina, subito pubblicate, in una sequenza oltretutto arbitraria e tendente a colpevolizzare quello che in fin dei conti è stato un omicidio non voluto, scatenarono un vero e proprio “linciaggio mediatico”. Uno dei partecipanti, Mario Rossi, venne arrestato immediatamente dopo l’accaduto. Subito dopo viene arrestato un “perfetto estraneo” Salvatore Ardolino, solo sulla base del fatto che viene trovato intento a vestirsi da donna, e quindi sospettato di voler evitare la propria identificazione, poi costui confessa tutto quello che gli inquirenti vogliono, inventandosi tutto di sana pianta, e addirittura viene trovato positivo alla prova del “guanto di paraffina”, il che deve far riflettere sull’attendibilità di simili prove, dato anche che poi risulterà del tutto estraneo ai fatti.
Comunque le indagini proseguono, in un clima di “demonizzazione” anche da parte del Pci locale, e piano piano viene smantellato tutto il gruppo, che tra l’altro non si era neanche dato “un nome”; il nome 22 Ottobre lo dà a loro la stampa partendo da un biglietto ferroviario trovato nelle tasche di Mario Rossi, e questa rapina finita male viene collegata alle altre azioni del gruppo, o meglio ad alcune delle altre azioni del gruppo, perché ad esempio l’incendio di un camion militare americano -trasportante armi per i soldati americani in Vietnam- non gli viene attribuita dagli inquirenti perché magistrati e “benpensanti” chiamiamoli così, cercano in ogni modo di dipingerli come “delinquenti comuni” e di non dare risalto all’aspetto politico delle loro azioni. Sono interessanti e significative anche le interferenze realizzate dal gruppo sui programmi televisivi, realizzate confrontandosi dialetticamente con “altre idee” di Feltrinelli, una sorta di ” hackeraggio ante-litteram”, in cui (ma qui vado oltre il testo di Piano) possono essere considerati i precursori di azioni realizzate nei giorni nostri su internet.
Il Pci locale, dal canto suo cerca addirittura, almeno in un primo momento del processo, basandosi sul fatto che ad una delle azioni aveva collaborato un pregiudicato comune di chiare simpatie di destra, di farli passare come fascisti. E questo perché era profondamente scomodo per un Pci sempre più orientato quantomeno alla convivenza, per usare un termine moderato, con “lo status quo”, riconoscere che delle azioni di lotta , in realtà poi, secondo me, anche “non troppo violente” perché nel “curriculum” del gruppo troviamo soprattutto attentati contro “cose”e non contro “persone”, ma per il Pci locale stavo dicendo, era molto scomodo riconoscere che delle azioni “di lotta armata” fossero state portate avanti da degli elementi che perlopiù si erano formati o comunque “gravitavano” attorno al Pci.
Come scrive Franco Fratini nella sua introduzione all’opera, “All’inizio degli anni Settanta la Resistenza era finita da trent’anni, ma molti a sinistra sia fuori che dentro il Pci desideravano che quella lotta e quella guerra di liberazione venissero riprese e infine portate a termine, e continuavano ad adoperarsi per farlo.”(4) Io però aggiungo: non certo però i vertici del Pci, (tranne isolate eccezioni) neppure a livello “genovese locale”
Il libro di Paolo Piano ricostruisce la storia dei vari componenti del gruppo, avvalendosi della testimonianza diretta di molti dei protagonisti. Sono storie di proletari che progressivamente sviluppano la loro coscienza politica a contatto con le difficili condizioni materiali del dopoguerra. E ricostruisce anche le fasi del processo che durerà per circa quattro anni, e, anche se terminerà con condanne molto pesanti, vedrà il progressivo formarsi di un largo “credito politico” a favore del gruppo, che culminerà con la richiesta delle Brigate Rosse, in occasione del sequestro del giudice Mario Sossi, (che, tra le altre cose, era quello che fungeva da pubblico ministero durante il processo alla “22 Ottobre”) della liberazione di 8 membri del Gruppo XXII Ottobre. La Corte d’assise d’appello di Genova il 20 maggio 1974 diede parere favorevole alla libertà provvisoria. Ma il procuratore della Repubblica Francesco Coco si oppose al mantenimento dell’impegno (5).
Concludono il volume vari documenti tra cui quelli del soccorso rosso e i comunicati sul tema delle Br. Al volume è allegato un dvd con le interviste ad alcuni dei protagonisti. Un testo molto interessante per chiunque sia interessato alla storia di quegli anni.
(1)Donatella Alfonzo, Animali di periferia. Le origini del terrorismo tra Golpe e Resistenza tradita. La storia inedita della Banda XXII Ottobre, Castelvecchi, Roma, 2012.
(3) Paolo Piano “La <<banda 22 ottobre>> – Agli arbori della lotta armata in Italia”, ed. DeriveApprodi, II edizione riveduta e corretta, Roma 2008.
(4) Paolo Piano, op.cit. Pag.23
(5) fonte: Wikipedia
Che cos’è il carcere.
Pubblicato: novembre 26, 2020 Archiviato in: Carcere, Lotte, Repressione, Uncategorized | Tags: Carcere, Lotte Lascia un commento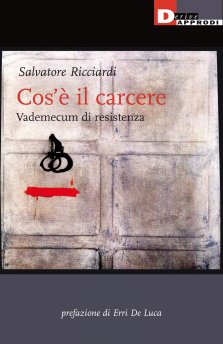
(La scomparsa del Salvatore Ricciardi nella primavera del 2020 è stata una perdita inestimabile per la coscienza morale e civile dell’Europa, il meno che si possa fare è mantenere vivo il dibattito sulle sue idee. La recensione che segue è stata già da me, pubblicata altrove, molto tempo fa, tuttavia mantiene tutta la sua attualità)
Ci sono molte esperienze, in vario grado “incomunicabili”, ossia esperienze che non possono essere efficacemente descritte a chi non le ha provate. L’esperienza della detenzione è tra queste. Salvatore Ricciardi, il quale è passato attraverso numerose esperienze di lotta per approdare alle Brigate Rosse e per sopravvivere a una lunghissima detenzione senza mai pentirsi nè dissociarsi, nella sua opera “Cos’è il carcere. Vademecum di resistenza”(1), prova a fornire una descrizione del carcere e contemporaneamente a dare a chi legge qualche idea su come sopravvivere psicologicamente a questa esperienza. Lo fa partendo dal suo “ritornare” al carcere da libero, chiedendosi esplicitamente quali siano le ragioni di questo ritorno. Domanda che troverà una sua compiuta risposta solo alla fine del libro, tra descrizioni di esperienze personali dell’autore, citazioni di opere di altri, e lettere dal carcere, di ieri e di oggi.
L’opera procede in modo assolutamente non lineare, alternando analisi, riflessioni, ricordi su temi e “su piani” diversi. Diversi temi ricorrono ciclicamente, vengono proposti per poi venire momentaneamente accantonati solo per ritornare “ampliando il discorso”. Si potrebbe, con una certa libertà descrittiva, paragonare la scrittura del Ricciardi in questo testo, alle opere liriche di Wagner, con leit-motiv che ritornano, ampliati, in chiavi diverse etc.
L’autore al principio analizza la sofferenza e la nozione di “accettabilità” di una sofferenza: “Quanto sia <<accettabile>> una sofferenza lo può decidere solo chi la subisce; ciascuno ha il suo limite che non è misurabile.” (2). Un nodo fondamentale è quello del concetto di tempo, il tempo ha una sua dimensione storica che deve far riflettere sulla transitorietà stessa del carcere, ma che per il soggetto che è detenuto è sperimentato come immobile, anche se si possono individuare dei momenti particolari come ad es. Il momento dell’arresto. Di qui anche il tema del ritorno al carcere: “Ci torni [in carcere] perchè quando ne hai fatta tanta di galera, e le sei stato ostile, tra te e lei si è aperto uno scontro mortale: o tu o lei. E’ una sfida che riguarda tutti i <<bravi ragazzi>> [termine del gergo carcerario che l’autore spiega come definente i detenuti solidali e ostili al carcere] e termina solo con la morte di una dei due.” (3). Un certo spazio è dedicato alle sensazioni fisiche, sapore, odori etc. Alla presenza degli altri, all’udito, alla cura di sè che più avanti nel libro viene quasi presentata come uno strumento di sopravvivenza. “Ma qui, in galera, ogni sensazione si tinge di colori forti. Gli stessi colori del ferro delle sbarre e della porta blindata”(4). In carcere, anche se vivi in mezzo agli altri, sei solo. Solo partendo da questo si può esaminare le relazioni tra detenuti.
“L’unica cura è ancorarsi alla concretezza dell’odio verso il carcere pensando, progettando e producendo rivolte o evasioni. E’ l’unico modo per restare sani, per evitare di essere stritolati dalla galera.”(5). Anche di qui l’esame del carcere procede su diversi piani, tra l’esame del suo ruolo sociale, i rapporti con il mondo “produttivo”, e di nuovo si affronta da più “prospettive” il problema del tempo e dei metodi per sopravvivere all’immobilità di questo in carcere: “Il tempo lo prende in consegna il carceriere”(6). E’ solo quando nel carcere scoppia una rivolta che il detenuto vive un tempo analogo a quello dei non-detenuti.
L’identità soggettiva è data (anche) dalle relazioni; Ricciardi illustra come la detenzione distrugga (almeno in parte) l’identità del soggetto precedente all’esperienza detentiva: “Prima di ogni altra condanna scatta il tempo della degradazione. Prima quella sociale, poi quella individuale” (7). L’autore ritorna poi al rapporto tra il detenuto e il proprio corpo, con uno sguardo quasi da antropologo parla delle auto-mutilazioni, dei tatuaggi, dell’urlo delle rivendicazioni corporee che in carcere diventano dominanti. E riflette (di nuovo) sulla sofferenza: “La sofferenza divide, non è vero che la sofferenza accomuna. Se soffri ti dà fastidio qualsiasi presenza, a meno che non sia totalmente dedicata ad accudirti e confortarti per lenire la tua sofferenza” (8).
Come contrastare l’annientamento? Il metodo implicitamente ed esplicitamente sostenuto dal Ricciardi è la rivolta, sia individuale sia soprattutto, collettiva: “Quando il carcerato cessa di essere ripiegato su sé stesso e, insieme ad altri, combatte la sofferenza che lo isola, inizia un percorso collettivo di contrasto all’annientamento” (9). Poi esistono metodi secondari e piccole regole.
Ci sono differenze tra carcere e carcere: “L’obbiettivo però è lo stesso: debilitare il corpo per sottomettere la volontà”(10). Questo viene perseguito in vari modi ma “anche Gramsci nelle sue lettere dal carcere annotava che il sistema carcerario <<manifesta la sua crudeltà non in efferatezze o sadismi, bensì nel tran-tran burocratico della detenzione, delle piccole vessazioni…>>” (11).
Un’altro elemento importante dell’esperienza detentiva è l’assenza di comunicazione da parte dei detenuti soprattutto verso l’esterno del carcere. E’ il carcere invece che si espande verso l’esterno, mentre una forma molto crudele di tortura carceraria è la “deprivazione sensoriale” impiegata nell’ex Germania Ovest.
Il carcere è uno strumento unicamente repressivo, mai però separato dal resto dello “sfruttamento produttivo”. Conclude il volume un dizionarietto dei termini del gergo carcerario, ma prima di questo, come conlusione, riporto le parole dell’autore che chiudono l’opera: “Ora ho capito il vero motivo di questo ritorno. Sono tornato in carcere per sentire di nuovo il sapore acre dell’odio verso la galera, per esserne di nuovo contagiato, non per portarlo via. [….] Sentirsi liberi di <<sciegliere>> di poter odiare il carcere, e la struttura sociale che lo produce e lo riproduce, è parte fondamentale della lotta per la libertà […..] L’odio verso il carcere ci aiuta a individuare i veri nemici e lottarci contro. La battaglia contro il carcere va intensificata con la convinzione che stavolta non siano i detenuti a soccombere ma il carcere. Che finisca! Che venga abolito![…]”(12)
(1) Salvatore Ricciardi, Cos’è il carcere. Vademecum di resistenza, ed. DeriveApprodi, Roma 2015
(2) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 13
(3) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 19
(4) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 28-29
(5) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 39
(6) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag.48
(7) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 54
(8) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 60
(9) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag.69
(10) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 76
(11) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 81
(12) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag.97
“Guida pratica al sabotaggio dell’esistenza”
Pubblicato: aprile 7, 2020 Archiviato in: letteratura, Uncategorized | Tags: letteratura Lascia un commento
(inedito, scritto durante il lockdown del Marzo-Aprile 2020. In seguito pubblicato altrove)
Durante questi giorni “di arresti domiciliari” per la maggior parte della popolazione, tutt* noi riflettiamo sulla morte, (dato che l’attenzione dei più, se non di tutt*, è su tematiche lugubri), e proviamo – in misura diversa – solitudine e/o alienazione. Può quindi essere interessante, o quantomeno è coerente con questa situazione, parlare di un romanzo che tratta questi temi, indubbiamente “da sinistra”. Il protagonista di questo romanzo, a un certo punto fa una sorta di dichiarazione di intenti programmatica, che riflette il pensiero del suo autore. “Decisi di scrivere un libro, tenendo bene in mente che un bildungsroman autentico non può che concludersi con una presa nel culo” (1) afferma il protagonista di “Guida pratica al sabotaggio dell’esistenza”(2). Al contrario del suo personaggio, che viene dissuaso dal compiere la sua opera letteraria dall’apparizione nientemeno che di Pirandello che lo invita a smettere, e quindi c’è la rinuncia a scrivere, come nel corso del romanzo altre forme d’arte verranno tentate dal protagonista che ne viene dissuaso da “qualche autorità nel campo”, il Roberto Mandracchia fattualmente ….scrive un romanzo, che è quello di cui parliamo. Come dunque evitare “la presa nel culo” ? Non solo svincolandosi “dai canoni” di quello che è il “bildungsroman autentico”, ma soprattutto concludendo la vicenda non con la maturazione dell’adolescente protagonista, né tantomeno con un finale in qualche modo “aperto”, ma concludendolo con una morte annunciata. La morte, la solitudine, l’estraneamento da una realtà in cui non c’è nulla di positivo, sono, come ho già scritto, tra i temi di questo romanzo. Anche l’amore è tutto, tranne “l’incontro tra due anime” , ed è simbolico che, in questo romanzo, fin dalla sua prima apparizione il colore associato alla ragazza amata dal protagonista è il bianco (3)….ricordate cosa scrive ad es. Melville del colore bianco ? Nei loro incontri “intimi” non c’è mai “congiunzione”, solo “danni fisici” fatti o subiti (che non sono neppure fonte di piacere, ma solo il segno dell’incapacità reciproca a relazionarsi in altro modo) il dialogo è ….Molto poco, certo non uno scambio tra punti di vista diversi, la massima espressione d’amore diviene rendere l’altro una sorta di oggetto, trasformandolo in una specie di messaggio in bottiglia per il mondo esterno “Mi piace pensarti come quei manufatti terrestri che vengono infilati dentro delle capsule lanciate poi nello spazio -un po’ come hanno fatto con i dischi dei Beatles e le variazioni Goldberg [….] Nell’eventuale caso che le forme di vita aliene, venendone a contatto, si rendano conto dei livelli che hanno raggiunto i terrestri” (4). Quindi non c’è il riconoscimento dell’altro (in questo caso altra) come persona, ma una mera proiezione del sé, che a un certo punto viene “ritirata” , infatti la donna amata – Marta – a un certo punto scompare, per ritornare solo come allucinazione (della cui illusorietà il protagonista è totalmente consapevole) al momento della morte dello stesso. Il sesso c’è, ma ha valenze unicamente negative, dalle molestie subite dal sacrestano, fino all’erotomania che porterà alla morte il padre del protagonista…La famiglia del protagonista è formata da persone concentrate su sé stesse, che vengono “portate via” dai loro stessi limiti (il padre, come ho già ricordato muore a causa della sua infedeltà, la madre impazzisce per il senso di colpa e finisce in una casa di cura); un nonno pur disponibile è comunque “perso nei suoi pensieri e nei suoi ricordi”. L’unico grande amico Gero, ha valenze ambigue, un po’ cerca di salvare il protagonista – in primis dalla sua relazione con Marta, cosa questa che non depone gran che a suo favore – un po’ è sostanzialmente indifferente alla sua sorte, e finisce per “diventare qualcuno” nel mondo dei soldi e della finanza. Dell’istituzione scolastica emerge solo la ripetitività (se non la reazionarietà) dell’insegnamento. Il contesto storico – Agrigento contemporanea – è molto delineato, ma presenta solo aspetti negativi. “Garogenti [ Agrigento N.d.R.] non era una città, ma la parodia grottesca di una città. Garogenti era un’accozzaglia di logore quinte teatrali. I suoi abitanti non avevano nulla dei cittadini, ma degli attori, dei saltimbanchi, degli istrioni” (5). Nel corso dell’opera si ritornerà con varie metafore sulla “pochezza morale” della vita nella cittadina.Si parla nonostante tutto, anche di problemi storico-sociali. Per esempio la mafia c’è, (e influisce nelle vicende del romanzo) ma è quasi un’elemento del paesaggio, perde i connotati di fenomeno da combattere, per parere quasi una fatalità della natura anche quando uccide, ma di cui si mostrano anche gli aspetti banali e le piccole miserie …Il protagonista non conosce l’impegno politico se non come fantasia-sogno-reminescenza; ritroviamo in questi termini la lotta armata (6), il Maggio francese (7), ma anche – con una sorta di rovesciamento – il Cile di Pinochet (8). Date queste premesse, non sorprende che i termini di “spazio-tempo” vengano messi in dubbio dal protagonista: “Forse non mi trovo a Garogenti e non mi trovo persino sulla terra. Forse sono su un altro pianeta o su un astronave che è una costruzione composta da due cubi uno più piccolo, l’altro più grande” (9). Quali vie di fuga restano? I tentativi artistici vengono frustrati -lo ripeto- dall’intervento di varie figure (ho già ricordato ad es. l’apparizione di Pirandello). Le droghe accentuano solo il senso di estraneità e lo spaesamento, l’eroina poi, con le sue crisi d’astinenza, “peggiora la situazione”. Rimane solo la morte. A noi, “in contesto diverso” spetta il difficile compito di trovare altre soluzioni. Il merito del romanzo è però quello di porre il problema; se ci suggerisse anche le soluzioni cadrebbe nel didattico, cosa che è raramente un pregio per un’opera d’arte, a meno che non si parli di Brecht. I problemi che esso affronta vanno al di là dell’adolescenziale; pongono interrogativi e dubbi a tutti noi. E, il Mandracchia, con una prosa che io paragonerei a quella per esempio della Isabella Santacroce nelle sue opere migliori, indubbiamente riesce “a farci riflettere”.
(1) Mandracchia Roberto, Guida pratica al sabotaggio dell’esistenza, Agenzia X ed. Milano 2010, pag.79
(2) op.cit.
(3) ibid. pag. 17
(4) ibid. pag. 122
(5) ibid. pag.20 . Comunque in più punti del romanzo si descrive la città siciliana con metafore poco lusinghiere.
(6) ibid. pag 53 -55
(7) ibid. pag. 74 -75
(8) ibid. pag. 112 -113
(9) ibid. pag. 56
“Maelstrom” di Salvatore Ricciardi
Pubblicato: aprile 5, 2020 Archiviato in: Carcere, letteratura, Lotte, Repressione Lascia un commento

(altra ri-pubblicazione)
“Non sono uno storico, sono uno che ha partecipato a quei fatti. Gli storici ci chiamano testimoni. Dunque come testimone non ho l’obbligo, che ha lo storico, di sistematicità narrativa, nè di quello di una scelta metodologica. Come testimone proverò a raccontare quello che ho fatto in vent’anni, da Porta San Paolo al carcere speciale.” (1)
Un libro molto utile a chi cerca di comprendere i fatti del recente passato (e non solo di quello) è senza dubbio il testo del Ricciardi, “Maelstrom – Scene di rivolta e di autorganizzazione di classe in Italia (1960- 1980)”. Salvatore Ricciardi, romano, nato nel 1940, ha vissuto in prima persona le lotte operaie dal 1960 in poi, attraverso numerose esperienze approdò alle Brigate Rosse, e dopo circa trent’anni di reclusione ha riacquistato la libertà intorno al 2012, ed è attualmente tra i redattori di Radio Onda Rossa a Roma.
Fin dalla prefazione, l’autore dichiara : “il racconto non risponde ai canoni del razionale e ordinato fluire dei fatti. A quei criteri si attengono spesso i racconti dei pentiti e dei dissociati, racconti ordinati ma non veri, nè nei fatti nè nelle emozioni.”(2) Questa scelta viene giustificata come garanzia di sincerità e di aderenza alla realtà, e bisogna aggiungere che l’abilità narrativa dell’autore è tale che la comprensibilità del testo non ne risente gran che, anche se il lettore si trova di fronte a salti in avanti e indietro nel tempo che possono rendere la lettura un pò più impegnativa rispetto ad opere analoghe.
Frequente è anche il richiamo dell’autore, nel raccontare esperienze di lotta vissute e fatti storici, all’attualità. Ad es. descrivendo la condizione dei lavoratori nei primi anni ‘60, gli anni del “boom economico”, il Ricciardi nota: “Erano tutti drogati dal <<boom>>. Il miraggio di arricchirti e riempirti di oggetti. Consumare dà dipendenza. I soldi che il <<boom>> prometteva erano la peggiore delle droghe, qualcosa del genere la stò vedendo in questi tempi, ma adesso la droga non è il <<boom>>, è la paura: se non lavori 24 ore al giorno <<esci dal mercato>>, così si dice in questi anni plumbei del nuovo secolo”(3).
Certe osservazioni sulla condizione operaia sono del resto rimaste attuali. “[il lavoratore] Deve trovare la forza e la capacità di rivoltarsi anche contro quella parte di sè che arricchisce il padrone. Deve lottare contro quel ruolo, quella funzione che lui stesso esercita lavorando; lui e i suoi compagni con il loro lavoro fanno crescere la ricchezza dei padroni. Si dice <<valorizzano il capitale>>, e quindi rafforzano il potere dei padroni che hanno più mezzi per tenere gli operai sottomessi.” (4)
Per quanto riguarda la storia di quegli anni, anche al di là dell’indubbio valore storico della testimonianza del Ricciardi, che sebbene non abbia quasi mai svolto ruoli di primissimo piano è stato tra “le prime file” dalle manifestazioni contro il governo Tambroni nel ‘60 fino alla rivolta del carcere speciale di Trani nel ‘80, và citata la sua valenza di “manifesto politico” i cui contenuti ci chiamano direttamente in causa. “La nostra ribellione non era una richiesta di migliorare di poco o di tanto le nostre condizioni. Non volevamo un governo buono da sostituire a quello cattivo, corrotto e mafioso. Volevamo semplicemente mandarli via tutti, i cattivi e i buoni, pochè eravamo convinti che le persone devono organizzare autonomamente la propria vita, quanto e quando lavorare, cosa produrre, come distribuire ecc.” (5).
L’esperienza del carcere si intreccia alla narrazione dei vari eventi, anche quando, come in buona parte del libro, è cronologicamente “sfalsata”. E, le vicende del mondo del carcere, non sono per nulla separate da quelle del resto della società. Tutto il contrario. “Il carcere rimane comunque ancora all’interno del conflitto capitale-lavoro, là dove è sorto. Prima aveva la funzione di governare il prezzo della forza lavoro […] Oggi non più, oggi l’offerta di braccia viene regolata attraverso la migrazione, le <<quote>> di immigrazione sono le richieste dei padroni, il carcere accoglie gli scarti, quelli che non servono, quelli da espellere. Così il carcere ha partorito il suo prolungamento: il Centro di espulsione (Cie).” (6) E ancora: “Ci sono testimonianze di boss mafiosi in carcere che si stupivano come mai venissero considerati <<nemici dello Stato>> quando confessavano amichevolmente ai direttori delle carceri di perseguire lo stesso obbiettivo: ridurre all’obbedienza le giovani teste calde, i ribelli.” (7) A sua volta il carcere influenza il resto della società: “I valori trionfanti nella società in questo Ventunesimo secolo sono quelli dell’arricchirsi, dell’affermarsi e far carriera, l’ideologia in voga è <<riuscire>>, sfondare, primeggiare. Da dove provengono questi valori? Dalla malavita organizzata, dalle mafie e dalle camorre, da quella criminalità che in carcere dominava prima delle rivolte, ed è tornata a dominare quando lo Stato ha sconfitto la sovversione.” (8) E, dalla condizione di “detenuto in lotta”, Ricciardi trae importanti insegnamenti per ogni rivoluzionario/a, che travalicano l’orizzonte propriamente carcerario: “ Devi essere in guerra permanente col carcere, altrimenti il carcere ti uccide dentro. Non chiedete mai quali ragioni hanno spinto uno o più detenuti a un atto di ribellione individuale o a una rivolta collettiva. Se lo chiedete non conoscete affatto la galera. Il motivo di una ribellione, di una rivolta, è sempre in primo luogo, l’esistenza stessa del carcere. Lo stesso ragionamento dovrebbe valere per ciascun sistema di potere: Stato, lavoro, famiglia, chiesa, coppia, scuola ecc., queste <<istituzioni totali>> se non le contrasti giorno dopo giorno ti entrano dentro, ti catturano e tu diventi parte di esse.” (9)
Nella postilla alla seconda edizione l’autore arriva ad affermare, a proposito del non-luogo del carcere: “Lì si compie la tragedia dell’uomo, un uomo-nudo, senza orpelli nè mediazioni sociali. La tragedia tra uomo libero e uomo sottomesso al potere, l’essenza di ogni tragedia”(10).
1) Salvatore Ricciardi, Maelstrom – Scene di rivolta e di autorganizzazione di classe in Italia (1960- 1980) DeriveApprodi ed. Seconda edizione riveduta e corretta, Roma 2012; pag. 14
(2)Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 14
(3)Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 63
(4)Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag.152
(5) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 154
(6)Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 384
(7)Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 172-173
(8) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 202
(9) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 76
(10) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag.395
La filosofia di P.K.Dick
Pubblicato: marzo 31, 2020 Archiviato in: letteratura | Tags: letteratura Lascia un commento(altra ri-pubblicazione, con minime modifiche)
L’influenza (ma anche il fraintendimento e/o la banalizzazione) dell’opera di Philip K. Dick nell’immaginario contemporaneo è enorme. Si pensi ad es. ai film ispirati alle sue opere da “Blade Runner”, a “Minority Report”, passando per “Atto di forza”. E’ quindi interessante da più punti di vista esaminare la sua ideologia.
Un’esposizione abbastanza dettagliata e coerente di questa è presente in “Se vi pare che questo mondo sia brutto” (1). Naturalmente, come per ogni autore bisognerebbe parlare di varie “fasi”, nessuno scrittore è mai stato perfettamente coerente e lineare nel corso di tutta la sua carriera, tuttavia i tre saggi che compongono il volume danno una buona approssimazione dello sviluppo del suo pensiero. Vi anticipo subito che il seguito della frase del titolo è “dovreste vederne qualche altro”, se pensate che questo mondo sia brutto dovreste vedere gli altri. L’autore parte dalla considerazione che siamo sempre più circondati da quelli che oggi si chiamano “aggeggi smart”, apparentemente dotati di vita propria, e, in un certo senso di anima. Chiaramente una macchina, o è prevedibile o non è una macchina, ma la crescente complessità degli algoritmi che stanno alla base del funzionamento dei nostri lavastoviglie, lavatrice etc. potrà, in un prossimo futuro, dar luogo a comportamenti da parte di essi, inaspettati, anche se certo non imprevedibili. Qui apro una parentesi c’è una grossa differenza tra un comportamento inaspettato e un comportamento imprevedibile. Se una persona che non ha mai visto un automobile, che non conosce il codice della strada, incontra improvvisamente un’auto a guida autonoma (2); quella che si guida da sola beh, la crederà capace di autodeterminazione, almeno al livelli di un animale, comunque di un essere “animato”, mentre sappiamo che non è così, sappiamo che essa segue le regole del codice della strada, e che fa quello e basta. Allora cos’è che distingue l’uomo dalla macchina? Questa è una domanda cruciale per il nostro futuro e nel primo dei saggi che compongono il volume Philip K. Dick articola una risposta a mio parere molto interessante. L’uomo può fare una scelta morale, anche una scelta irresponsabile – la macchina no- l’uomo può essere -di proposito- inaffidabile, la macchina no. La macchina agisce in base ai suoi algoritmi etc. L’uomo, si comporta, o quantomeno dovrebbe comportarsi non in base a meccanismi. E così facendo, l’uomo crea la (sua) realtà; sceglie anche cosa considerare reale e cosa no (per esempio può scegliere di considerare come “non reali” le esperienze oniriche notturne). Un’automa invece non crea la sua realtà. Ora, a questo potremmo fare tutta una serie di obbiezioni, sia sul lato “Anche noi abbiamo i nostri meccanismi interni” sia dal lato “una macchina è reputata tanto più intelligente quanto le sue tra virgolette risposte sono indistinguibili da quelle umane”. Queste obbiezioni, anche se indirettamente vengono affrontate nel secondo dei saggi che compongono il volume: “Uomo, androide e macchina”.
Una macchina che interrompesse il suo programma per tornare a svolgerlo solo dopo una decisione consapevole agirebbe “umanamente”. Parlando della differenza tra uomini, androidi e macchine, viene fuori il tema dell’inganno, delle maschere perché qualcuno o qualcosa sembri ciò che non è (di nuovo una macchina è considerata tanto più intelligente quanto le sue risposte sono indistinguibili da quelle umane). E lì, bisogna dire, l’autore comincia ad andare sul mistico, perché secondo lui tutto quello che esiste “serve” a fin “di bene”, quindi visto che non è tutto rose e fiori quello che esiste bisogna che lo giustifichi in qualche modo, (in ultima analisi, la giustificazione di Dick è che non è “reale”). Anche il tempo è un inganno -sua concezione, peraltro molto ben articolata- ma comunque esso evolve verso il “disvelamento” finale. Anche noi abbiamo i nostri meccanismi interni -ma -e questa è la sua risposta all’obbiezione forse più frequente che si può muovere alla sua definizione della differenza tra uomo e macchina, anche questi fanno parte dell’inganno “a fin di bene”. Quindi arriva, a parlare dei rapporti tra conscio e inconscio, e su questa strada si arriva quindi alla sua concezione della divinità unica -si, perché secondo me uno dei più grossi limiti di Dick, che comunque è apprezzabile da una prospettiva materialista è quello di essere un monoteista d’acciaio, divinità che sarebbe immanente, in modo simile alle idee di Spinoza. Vi lascio senza “spoiler” il resto del saggio dicendovi solo che comunque è anche apprezzabilie -chiaramente fino a un certo punto- anche da una prospettiva materialista. La domanda “avrebbe la storia potuto andare anche in un altro modo? E cosa sarebbe successo allora?” è presente anche in autori ultra-materialisti, più o meno contemporanei del P.K.Dick -citerò per es. nel campo libertario il Murray Bookchin- e quella “cos’è davvero reale?” è presente per così dire in filigrana anche ad es. in molta letteratura marxista, per restare nel campo del materialismo. Più che per le risposte che P.K.Dick dà, secondo me è interessante leggerlo per le domande che lui si pone (e ci pone). Domande che hanno senso anche restando nel materialismo, e non necessariamente solo nel cosiddetto “materialismo dialettico”. Anche Il presunto fine della storia, o lo scopo di essa è comunque una domanda che viene fuori anche se non si legge P.K.Dick.
E queste domande sono alla base del terzo saggio del volume: “Se vi pare che questo mondo sia brutto, dovreste vederne qualche altro”. Qui l’autore espone le sue idee sul divenire storico e sulla struttura del reale. E di nuovo vi lascio senza “spoiler” pur avvertendovi che “và sul mistico”. Ma, ancora: quelle che sono interessanti sono le domande che l’autore si pone, domande che il tra virgolette “militante di sinistra” necessariamente affronta, anche se credo che pochi tra noi diano le stesse risposte del P.K.Dick, soprattutto nella sua fase più tarda e mistica.
(1)Philip K. Dick, Se vi pare che questo mondo sia brutto, Feltrinelli ed. Milano 1999
(2)https://it.wikipedia.org/wiki/Autovettura_autonoma
Caos & Cybercultura
Pubblicato: novembre 14, 2019 Archiviato in: Uncategorized | Tags: letteratura, varie Lascia un commento
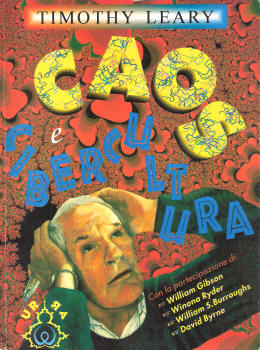
Confesso che con il passare degli anni sono sempre più scettico sulle supposte capacità di internet di giocare un ruolo positivo nell’evoluzione umana. Tuttavia rifiuto la volontà assolutamente politica di trattare il Timothy Leary come “un cane morto”, benchè il personaggio abbia comunque avuto i suoi demeriti (sarò esplicito su quali siano a mio avviso: Leary viene citato in positivo nell’opera famigerata del Thomas A. Harris “Io sono ok, tu sei ok”, libro che, bisogna ricordarlo, giustifica parte del peggio della psichiatria contemporanea (farmaci e persino elettroshock); dato questo, è evidente che anche il Leary i suoi sbagli li ha fatti). Vorrei che se ne tornasse a parlare “in modo pacato”. Ripubblico qui (con minime correzioni) perciò un mio vecchio articolo su “Caos & Cybercultura”.
Uno dei libri, a mio avviso, “indispensabili” per capire il mondo e ciò che stiamo vivendo è “Caos e Cibercultura” del Timothy Leary” (1).
Dirò subito che su un paio di specifici argomenti – la giustificazione da parte dell’autore dell’esistenza dei cosiddetti “Young Urban Profesionals”, meglio noti con l’acronimo di YUPPIE; e l’analisi fatta del fenomeno della morte- non mi sento in accordo, con le tesi esposte. Peraltro l’ottimismo di Leary giustifica – a volte- la critica che rivolge al suo autore, la Joanne Kyger: “Pagine insaporite di parole come: un tipo dolcissimo, una nuova terapia che è una delizia, un pomeriggio che è un amore. [….]”(2).
Tutto ciò, però non sminuisce l’importanza dell’opera, una delle poche che indaghi con intelligenza e completezza sull’avvento della moderna civiltà informatica.(3)
L’autore, seppure da una prospettiva radicalmente diversa da quella dei classici apologeti dell’esistente (ricordate, ad es. le illusioni di “fine della storia” pre 11 Settembre 2001?) descrive – in fondo profeticamente, visto che il libro è del 1994 – l’avvento della moderna civiltà informatica nei termini di un salto evolutivo, analogo a quello – citato espressamente – che portò i nostri progenitori fuori dall’acqua e alla conquista della terraferma.
Gli orrori della civiltà industriale (alcuni dei quali descritti e analizzati esplicitamente, come il militarismo americano, altri impliciti, come lo sfruttamento capitalista delle masse) non vengano negati nè giustificati, ma finiscono per apparire come una fase transitoria, ancorchè necessaria, dell’evoluzione.
La civiltà informatica, finirà, a suo avviso, per superare molte delle atrocità della modernità capitalista.
Lo sguardo di Leary indaga lucidamente sullo sviluppo della coscienza umana partendo, se così possiamo dire, dai fondamenti. La sua esperienza di psicologo giunge, non solo a descrivere il funzionamento del cervello umano con analogie prese dal mondo dei computer, ma anche ad indagare le modificazioni profonde che l’interazione con questo mondo comporta.
L’essere umano però non risultà nè disumanizzato nè “disincarnato” anzi, al contrario solo con l’avvento dell’informatica possono emergere, da un lato le sue vere peculiarità ( “I computer non sostituiranno la gente vera, ma solo i burocrati a livello medio e basso. Sostituiranno voi soltanto nella misura in cui usate l’intelligenza artificiale ( e non quella naturale) nel vostro lavoro e nella vostra vita. Se pensate come un burocrate, come un funzionario, come manager, come membro di una grande organizzazione nella quale non si fanno domande, o come giocatore di scacchi, allora state attenti….” (pag. 33 ), dall’altro solo il computer può rendere al corpo la sua importanza: “Il primo fatto da tenere presente è: noi tricelebrali non dovremmo usare il nostro prezioso corpoware per lavorare. Non è un sacrilegio sprecare i nostri preziosi sistemi sensoriali nello sgobbare, faticare, travagliare? Non siamo animali da soma, o servi della gleba, o robot esecutivi in divisa che debbano trascinare in ufficio il ventiquattrore. Perchè mai dovremmo usare i nostri corpi preziosi e insostituibili per fare lavori più indicati per le macchine della catena di montaggio?” (pag.5 ).
L’indagine procede anche conversando con protagonisti della cultura di quegli anni, come W. Gibson, W.S.Burroughs, Winona Ryder e altri. La vastità e la natura degli esempi e dei campi d’indagine esposti non mi permettano una sintesi esauriente, nella scarsità di tempo che la pazienza del lettore/lettrice può concedere a me; basti dire che l’indagine del Leary esplora a 360 gradi, non solo, come ho già ricordato, l’intera coscienza dell’uomo, ma altresì l’intero corso evolutivo dell’umanità, nel momento appunto di questa svolta cruciale, il passaggio a una società basata sull’informazione.
Uno dei “leit-motiv” è comunque il rapporto autorità- individuo che il Leary (a mio parere, giustamente) risolve a favore di quest’ultimo, dopo averlo esaminato nella sua evoluzione storica. Il Leary è inoltre convinto che le moderne tecnologie faranno “pendere la bilancia” sempre più a favore di quest’ultimo, e ne espone esaurienti ragioni.
Coerentemente con questo, posso ricordare – e condividere – lo slogan dell’opera, sintetizzato con l’acronomo TFYQA ossia Think for yourself; question authority, grosso modo traducibile come: “Pensa per te stesso, metti in discussione le autorità”.
Per concludere lascio la parola all’autore medesimo:
“I proprietari di Personal Computer stanno scoprendo che il cervello è:
- l’organo definitivo del piacere e della consapevolezza;
- una matrice di cento miliardi di microcomputer che attendono il boot, l’attivazione, la stimolazione, la programmazione;
- in impaziente attesa di software, testaware, pensieroware, che ne riconosca l’impressionante potenziale e che renda possibile il collegamento elettronico in inter-rete con altri cervelli.”(4)
Il vostro affezionatissimo
(1)Timothy Leary, Caos e Cibercultura, Milano, Ed. Urra-Apogeo, 1996. Il titolo originale è “Chaos & Cyber Culture” ma evidentemente l’editore, (o, meno probabilmente: il traduttore) riteneva “troppo anglofono” per quegli anni, scrivere “cybercultura” con la y, dimostrando così poca preveggenza…. Comunque rimane una pregevole edizione, splendidamente illustrata, il cui principale difetto è l’assenza di un indice analitico….
(2) dal diario indiano della Kyger, presente nell’antologia “The Beat Book: poesie e prose della Beat Generation” a cura di Anne Waldman, Milano,il Saggiatore, 1996, pag. 227
(3) Purtroppo è piuttosto sconfortante notare come qualsiasi discorso, e la maggioranza dei testi sul tema “informatica, società e individuo” non esca dai due consueti binari, ossia la falsa alternativa del pessimista “Come internet sostituisce i rapporti umani” e dell’idiota apologia “Come internet ingrassi i profitti delle aziende, ossia dei soliti pescecani”.
(4) Op. Cit. Pag 50.