“Sorry we missed you”
Pubblicato: aprile 1, 2022 Archiviato in: Uncategorized Lascia un commento
(ripubblicazione con minime modifiche, data la continua attualità del tema)
L’attuale tendenza a mascherare lo sfruttamento del lavoro tramite un’apparente auto-imprenditoria, e soprattutto il mondo delle consegne a domicilio, ultima frontiera della “modernità” capitalistica, sono al centro dell’ultimo lavoro di Ken Loach, “Sorry we missed you”.
Il protagonista Ricky decide di diventare un corriere, teoricamente “freelance”, ma in pratica completamente subordinato ad una ditta di consegne a domicilio di articoli vari. Però, per far quello deve comprare un furgone e, per acquistarlo convince la moglie a vendere la sua auto (e di conseguenza lei dovrà prendere ogni giorno l’autobus nei suoi spostamenti come badante). Questo lavoro si rivela devastante per l’intero nucleo familiare, non solo per i ritmi disumani (oltre al resto, gli autisti sono anche costretti a urinare in una bottiglia per rispettare i tempi) ma anche perché il protagonista per portarlo avanti è costretto a trascurare la famiglia, e soprattutto i problemi adolescenziali del figlio maggiore che finisce anche per commettere un piccolo furto. Anche la moglie ha i suoi problemi con il suo lavoro – che comunque le permette di sviluppare un profondo rapporto con le persone che assiste – e la mancanza dell’auto si fà sentire. Dopo varie vicessitudini, il protagonista viene assalito sul lavoro, pestato e derubato della merce che doveva consegnare. Ma il suo capo chiarisce che, a causa di questo furto e dei danni conseguenti, gli verrà chiesto di pagare di tasca propria una cifra altissima per risarcire l’attrezzatura rotta e le cose che gli sono state rubate. Il film si chiude con il protagonista che in un estremo tentativo di “sbarcare il lunario” si mette alla guida del furgone ancora con un occhio bendato e il resto del corpo pesantemente segnato….non cè una fine speranzosa ma la cruda realtà.
Questo film illustra in maniera magistrale come il riscatto di un membro della classe operaia non possa passare per la ricerca di un chimerico “arricchirsi”. Questo è un punto estremamente importante per noi che ci troviamo a vivere in un momento in cui l’auto-sfruttamento indotto dalle illusioni del sistema capitalista è diventato una delle principali catene da infrangere per buona parte della classe operaia. Il mondo del lavoro specialmente quello “di consegne veloci” è dipinto con grande realismo e con grande maestria, così come emerge magistralmente la psicologia dei personaggi e l’attuale contesto storico. Qualche perplessità può emergere di fronte a una certa idealizzazione della famiglia, idealizzazione del resto piuttosto diffusa in un momento come questo nel quale essa appare l’unica certezza in un mondo dove le cose non sono quelle che appaiono.
Bisogna che il lavoratore lotti, come diceva il Ricciardi, anche contro quella parte di sé che arricchisce il padrone. E senza confidare su istituzioni come la famiglia che nonostante le (eventuali) buone intenzioni dei propri membri finiscono inevitabilmente per generare e tramandare violenza e oppressione.
E concludo con una frase di Ken Loach “Questo capitalismo è intollerabile”
Che cos’è il carcere.
Pubblicato: novembre 26, 2020 Archiviato in: Carcere, Lotte, Repressione, Uncategorized | Tags: Carcere, Lotte Lascia un commento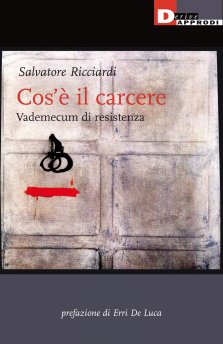
(La scomparsa del Salvatore Ricciardi nella primavera del 2020 è stata una perdita inestimabile per la coscienza morale e civile dell’Europa, il meno che si possa fare è mantenere vivo il dibattito sulle sue idee. La recensione che segue è stata già da me, pubblicata altrove, molto tempo fa, tuttavia mantiene tutta la sua attualità)
Ci sono molte esperienze, in vario grado “incomunicabili”, ossia esperienze che non possono essere efficacemente descritte a chi non le ha provate. L’esperienza della detenzione è tra queste. Salvatore Ricciardi, il quale è passato attraverso numerose esperienze di lotta per approdare alle Brigate Rosse e per sopravvivere a una lunghissima detenzione senza mai pentirsi nè dissociarsi, nella sua opera “Cos’è il carcere. Vademecum di resistenza”(1), prova a fornire una descrizione del carcere e contemporaneamente a dare a chi legge qualche idea su come sopravvivere psicologicamente a questa esperienza. Lo fa partendo dal suo “ritornare” al carcere da libero, chiedendosi esplicitamente quali siano le ragioni di questo ritorno. Domanda che troverà una sua compiuta risposta solo alla fine del libro, tra descrizioni di esperienze personali dell’autore, citazioni di opere di altri, e lettere dal carcere, di ieri e di oggi.
L’opera procede in modo assolutamente non lineare, alternando analisi, riflessioni, ricordi su temi e “su piani” diversi. Diversi temi ricorrono ciclicamente, vengono proposti per poi venire momentaneamente accantonati solo per ritornare “ampliando il discorso”. Si potrebbe, con una certa libertà descrittiva, paragonare la scrittura del Ricciardi in questo testo, alle opere liriche di Wagner, con leit-motiv che ritornano, ampliati, in chiavi diverse etc.
L’autore al principio analizza la sofferenza e la nozione di “accettabilità” di una sofferenza: “Quanto sia <<accettabile>> una sofferenza lo può decidere solo chi la subisce; ciascuno ha il suo limite che non è misurabile.” (2). Un nodo fondamentale è quello del concetto di tempo, il tempo ha una sua dimensione storica che deve far riflettere sulla transitorietà stessa del carcere, ma che per il soggetto che è detenuto è sperimentato come immobile, anche se si possono individuare dei momenti particolari come ad es. Il momento dell’arresto. Di qui anche il tema del ritorno al carcere: “Ci torni [in carcere] perchè quando ne hai fatta tanta di galera, e le sei stato ostile, tra te e lei si è aperto uno scontro mortale: o tu o lei. E’ una sfida che riguarda tutti i <<bravi ragazzi>> [termine del gergo carcerario che l’autore spiega come definente i detenuti solidali e ostili al carcere] e termina solo con la morte di una dei due.” (3). Un certo spazio è dedicato alle sensazioni fisiche, sapore, odori etc. Alla presenza degli altri, all’udito, alla cura di sè che più avanti nel libro viene quasi presentata come uno strumento di sopravvivenza. “Ma qui, in galera, ogni sensazione si tinge di colori forti. Gli stessi colori del ferro delle sbarre e della porta blindata”(4). In carcere, anche se vivi in mezzo agli altri, sei solo. Solo partendo da questo si può esaminare le relazioni tra detenuti.
“L’unica cura è ancorarsi alla concretezza dell’odio verso il carcere pensando, progettando e producendo rivolte o evasioni. E’ l’unico modo per restare sani, per evitare di essere stritolati dalla galera.”(5). Anche di qui l’esame del carcere procede su diversi piani, tra l’esame del suo ruolo sociale, i rapporti con il mondo “produttivo”, e di nuovo si affronta da più “prospettive” il problema del tempo e dei metodi per sopravvivere all’immobilità di questo in carcere: “Il tempo lo prende in consegna il carceriere”(6). E’ solo quando nel carcere scoppia una rivolta che il detenuto vive un tempo analogo a quello dei non-detenuti.
L’identità soggettiva è data (anche) dalle relazioni; Ricciardi illustra come la detenzione distrugga (almeno in parte) l’identità del soggetto precedente all’esperienza detentiva: “Prima di ogni altra condanna scatta il tempo della degradazione. Prima quella sociale, poi quella individuale” (7). L’autore ritorna poi al rapporto tra il detenuto e il proprio corpo, con uno sguardo quasi da antropologo parla delle auto-mutilazioni, dei tatuaggi, dell’urlo delle rivendicazioni corporee che in carcere diventano dominanti. E riflette (di nuovo) sulla sofferenza: “La sofferenza divide, non è vero che la sofferenza accomuna. Se soffri ti dà fastidio qualsiasi presenza, a meno che non sia totalmente dedicata ad accudirti e confortarti per lenire la tua sofferenza” (8).
Come contrastare l’annientamento? Il metodo implicitamente ed esplicitamente sostenuto dal Ricciardi è la rivolta, sia individuale sia soprattutto, collettiva: “Quando il carcerato cessa di essere ripiegato su sé stesso e, insieme ad altri, combatte la sofferenza che lo isola, inizia un percorso collettivo di contrasto all’annientamento” (9). Poi esistono metodi secondari e piccole regole.
Ci sono differenze tra carcere e carcere: “L’obbiettivo però è lo stesso: debilitare il corpo per sottomettere la volontà”(10). Questo viene perseguito in vari modi ma “anche Gramsci nelle sue lettere dal carcere annotava che il sistema carcerario <<manifesta la sua crudeltà non in efferatezze o sadismi, bensì nel tran-tran burocratico della detenzione, delle piccole vessazioni…>>” (11).
Un’altro elemento importante dell’esperienza detentiva è l’assenza di comunicazione da parte dei detenuti soprattutto verso l’esterno del carcere. E’ il carcere invece che si espande verso l’esterno, mentre una forma molto crudele di tortura carceraria è la “deprivazione sensoriale” impiegata nell’ex Germania Ovest.
Il carcere è uno strumento unicamente repressivo, mai però separato dal resto dello “sfruttamento produttivo”. Conclude il volume un dizionarietto dei termini del gergo carcerario, ma prima di questo, come conlusione, riporto le parole dell’autore che chiudono l’opera: “Ora ho capito il vero motivo di questo ritorno. Sono tornato in carcere per sentire di nuovo il sapore acre dell’odio verso la galera, per esserne di nuovo contagiato, non per portarlo via. [….] Sentirsi liberi di <<sciegliere>> di poter odiare il carcere, e la struttura sociale che lo produce e lo riproduce, è parte fondamentale della lotta per la libertà […..] L’odio verso il carcere ci aiuta a individuare i veri nemici e lottarci contro. La battaglia contro il carcere va intensificata con la convinzione che stavolta non siano i detenuti a soccombere ma il carcere. Che finisca! Che venga abolito![…]”(12)
(1) Salvatore Ricciardi, Cos’è il carcere. Vademecum di resistenza, ed. DeriveApprodi, Roma 2015
(2) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 13
(3) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 19
(4) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 28-29
(5) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 39
(6) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag.48
(7) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 54
(8) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 60
(9) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag.69
(10) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 76
(11) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag. 81
(12) Salvatore Ricciardi, op.cit. Pag.97
“Guida pratica al sabotaggio dell’esistenza”
Pubblicato: aprile 7, 2020 Archiviato in: letteratura, Uncategorized | Tags: letteratura Lascia un commento
(inedito, scritto durante il lockdown del Marzo-Aprile 2020. In seguito pubblicato altrove)
Durante questi giorni “di arresti domiciliari” per la maggior parte della popolazione, tutt* noi riflettiamo sulla morte, (dato che l’attenzione dei più, se non di tutt*, è su tematiche lugubri), e proviamo – in misura diversa – solitudine e/o alienazione. Può quindi essere interessante, o quantomeno è coerente con questa situazione, parlare di un romanzo che tratta questi temi, indubbiamente “da sinistra”. Il protagonista di questo romanzo, a un certo punto fa una sorta di dichiarazione di intenti programmatica, che riflette il pensiero del suo autore. “Decisi di scrivere un libro, tenendo bene in mente che un bildungsroman autentico non può che concludersi con una presa nel culo” (1) afferma il protagonista di “Guida pratica al sabotaggio dell’esistenza”(2). Al contrario del suo personaggio, che viene dissuaso dal compiere la sua opera letteraria dall’apparizione nientemeno che di Pirandello che lo invita a smettere, e quindi c’è la rinuncia a scrivere, come nel corso del romanzo altre forme d’arte verranno tentate dal protagonista che ne viene dissuaso da “qualche autorità nel campo”, il Roberto Mandracchia fattualmente ….scrive un romanzo, che è quello di cui parliamo. Come dunque evitare “la presa nel culo” ? Non solo svincolandosi “dai canoni” di quello che è il “bildungsroman autentico”, ma soprattutto concludendo la vicenda non con la maturazione dell’adolescente protagonista, né tantomeno con un finale in qualche modo “aperto”, ma concludendolo con una morte annunciata. La morte, la solitudine, l’estraneamento da una realtà in cui non c’è nulla di positivo, sono, come ho già scritto, tra i temi di questo romanzo. Anche l’amore è tutto, tranne “l’incontro tra due anime” , ed è simbolico che, in questo romanzo, fin dalla sua prima apparizione il colore associato alla ragazza amata dal protagonista è il bianco (3)….ricordate cosa scrive ad es. Melville del colore bianco ? Nei loro incontri “intimi” non c’è mai “congiunzione”, solo “danni fisici” fatti o subiti (che non sono neppure fonte di piacere, ma solo il segno dell’incapacità reciproca a relazionarsi in altro modo) il dialogo è ….Molto poco, certo non uno scambio tra punti di vista diversi, la massima espressione d’amore diviene rendere l’altro una sorta di oggetto, trasformandolo in una specie di messaggio in bottiglia per il mondo esterno “Mi piace pensarti come quei manufatti terrestri che vengono infilati dentro delle capsule lanciate poi nello spazio -un po’ come hanno fatto con i dischi dei Beatles e le variazioni Goldberg [….] Nell’eventuale caso che le forme di vita aliene, venendone a contatto, si rendano conto dei livelli che hanno raggiunto i terrestri” (4). Quindi non c’è il riconoscimento dell’altro (in questo caso altra) come persona, ma una mera proiezione del sé, che a un certo punto viene “ritirata” , infatti la donna amata – Marta – a un certo punto scompare, per ritornare solo come allucinazione (della cui illusorietà il protagonista è totalmente consapevole) al momento della morte dello stesso. Il sesso c’è, ma ha valenze unicamente negative, dalle molestie subite dal sacrestano, fino all’erotomania che porterà alla morte il padre del protagonista…La famiglia del protagonista è formata da persone concentrate su sé stesse, che vengono “portate via” dai loro stessi limiti (il padre, come ho già ricordato muore a causa della sua infedeltà, la madre impazzisce per il senso di colpa e finisce in una casa di cura); un nonno pur disponibile è comunque “perso nei suoi pensieri e nei suoi ricordi”. L’unico grande amico Gero, ha valenze ambigue, un po’ cerca di salvare il protagonista – in primis dalla sua relazione con Marta, cosa questa che non depone gran che a suo favore – un po’ è sostanzialmente indifferente alla sua sorte, e finisce per “diventare qualcuno” nel mondo dei soldi e della finanza. Dell’istituzione scolastica emerge solo la ripetitività (se non la reazionarietà) dell’insegnamento. Il contesto storico – Agrigento contemporanea – è molto delineato, ma presenta solo aspetti negativi. “Garogenti [ Agrigento N.d.R.] non era una città, ma la parodia grottesca di una città. Garogenti era un’accozzaglia di logore quinte teatrali. I suoi abitanti non avevano nulla dei cittadini, ma degli attori, dei saltimbanchi, degli istrioni” (5). Nel corso dell’opera si ritornerà con varie metafore sulla “pochezza morale” della vita nella cittadina.Si parla nonostante tutto, anche di problemi storico-sociali. Per esempio la mafia c’è, (e influisce nelle vicende del romanzo) ma è quasi un’elemento del paesaggio, perde i connotati di fenomeno da combattere, per parere quasi una fatalità della natura anche quando uccide, ma di cui si mostrano anche gli aspetti banali e le piccole miserie …Il protagonista non conosce l’impegno politico se non come fantasia-sogno-reminescenza; ritroviamo in questi termini la lotta armata (6), il Maggio francese (7), ma anche – con una sorta di rovesciamento – il Cile di Pinochet (8). Date queste premesse, non sorprende che i termini di “spazio-tempo” vengano messi in dubbio dal protagonista: “Forse non mi trovo a Garogenti e non mi trovo persino sulla terra. Forse sono su un altro pianeta o su un astronave che è una costruzione composta da due cubi uno più piccolo, l’altro più grande” (9). Quali vie di fuga restano? I tentativi artistici vengono frustrati -lo ripeto- dall’intervento di varie figure (ho già ricordato ad es. l’apparizione di Pirandello). Le droghe accentuano solo il senso di estraneità e lo spaesamento, l’eroina poi, con le sue crisi d’astinenza, “peggiora la situazione”. Rimane solo la morte. A noi, “in contesto diverso” spetta il difficile compito di trovare altre soluzioni. Il merito del romanzo è però quello di porre il problema; se ci suggerisse anche le soluzioni cadrebbe nel didattico, cosa che è raramente un pregio per un’opera d’arte, a meno che non si parli di Brecht. I problemi che esso affronta vanno al di là dell’adolescenziale; pongono interrogativi e dubbi a tutti noi. E, il Mandracchia, con una prosa che io paragonerei a quella per esempio della Isabella Santacroce nelle sue opere migliori, indubbiamente riesce “a farci riflettere”.
(1) Mandracchia Roberto, Guida pratica al sabotaggio dell’esistenza, Agenzia X ed. Milano 2010, pag.79
(2) op.cit.
(3) ibid. pag. 17
(4) ibid. pag. 122
(5) ibid. pag.20 . Comunque in più punti del romanzo si descrive la città siciliana con metafore poco lusinghiere.
(6) ibid. pag 53 -55
(7) ibid. pag. 74 -75
(8) ibid. pag. 112 -113
(9) ibid. pag. 56
Caos & Cybercultura
Pubblicato: novembre 14, 2019 Archiviato in: Uncategorized | Tags: letteratura, varie Lascia un commento
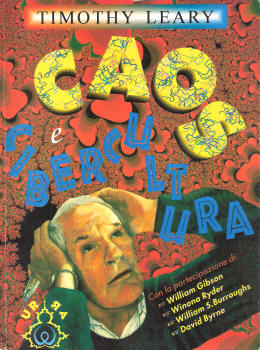
Confesso che con il passare degli anni sono sempre più scettico sulle supposte capacità di internet di giocare un ruolo positivo nell’evoluzione umana. Tuttavia rifiuto la volontà assolutamente politica di trattare il Timothy Leary come “un cane morto”, benchè il personaggio abbia comunque avuto i suoi demeriti (sarò esplicito su quali siano a mio avviso: Leary viene citato in positivo nell’opera famigerata del Thomas A. Harris “Io sono ok, tu sei ok”, libro che, bisogna ricordarlo, giustifica parte del peggio della psichiatria contemporanea (farmaci e persino elettroshock); dato questo, è evidente che anche il Leary i suoi sbagli li ha fatti). Vorrei che se ne tornasse a parlare “in modo pacato”. Ripubblico qui (con minime correzioni) perciò un mio vecchio articolo su “Caos & Cybercultura”.
Uno dei libri, a mio avviso, “indispensabili” per capire il mondo e ciò che stiamo vivendo è “Caos e Cibercultura” del Timothy Leary” (1).
Dirò subito che su un paio di specifici argomenti – la giustificazione da parte dell’autore dell’esistenza dei cosiddetti “Young Urban Profesionals”, meglio noti con l’acronimo di YUPPIE; e l’analisi fatta del fenomeno della morte- non mi sento in accordo, con le tesi esposte. Peraltro l’ottimismo di Leary giustifica – a volte- la critica che rivolge al suo autore, la Joanne Kyger: “Pagine insaporite di parole come: un tipo dolcissimo, una nuova terapia che è una delizia, un pomeriggio che è un amore. [….]”(2).
Tutto ciò, però non sminuisce l’importanza dell’opera, una delle poche che indaghi con intelligenza e completezza sull’avvento della moderna civiltà informatica.(3)
L’autore, seppure da una prospettiva radicalmente diversa da quella dei classici apologeti dell’esistente (ricordate, ad es. le illusioni di “fine della storia” pre 11 Settembre 2001?) descrive – in fondo profeticamente, visto che il libro è del 1994 – l’avvento della moderna civiltà informatica nei termini di un salto evolutivo, analogo a quello – citato espressamente – che portò i nostri progenitori fuori dall’acqua e alla conquista della terraferma.
Gli orrori della civiltà industriale (alcuni dei quali descritti e analizzati esplicitamente, come il militarismo americano, altri impliciti, come lo sfruttamento capitalista delle masse) non vengano negati nè giustificati, ma finiscono per apparire come una fase transitoria, ancorchè necessaria, dell’evoluzione.
La civiltà informatica, finirà, a suo avviso, per superare molte delle atrocità della modernità capitalista.
Lo sguardo di Leary indaga lucidamente sullo sviluppo della coscienza umana partendo, se così possiamo dire, dai fondamenti. La sua esperienza di psicologo giunge, non solo a descrivere il funzionamento del cervello umano con analogie prese dal mondo dei computer, ma anche ad indagare le modificazioni profonde che l’interazione con questo mondo comporta.
L’essere umano però non risultà nè disumanizzato nè “disincarnato” anzi, al contrario solo con l’avvento dell’informatica possono emergere, da un lato le sue vere peculiarità ( “I computer non sostituiranno la gente vera, ma solo i burocrati a livello medio e basso. Sostituiranno voi soltanto nella misura in cui usate l’intelligenza artificiale ( e non quella naturale) nel vostro lavoro e nella vostra vita. Se pensate come un burocrate, come un funzionario, come manager, come membro di una grande organizzazione nella quale non si fanno domande, o come giocatore di scacchi, allora state attenti….” (pag. 33 ), dall’altro solo il computer può rendere al corpo la sua importanza: “Il primo fatto da tenere presente è: noi tricelebrali non dovremmo usare il nostro prezioso corpoware per lavorare. Non è un sacrilegio sprecare i nostri preziosi sistemi sensoriali nello sgobbare, faticare, travagliare? Non siamo animali da soma, o servi della gleba, o robot esecutivi in divisa che debbano trascinare in ufficio il ventiquattrore. Perchè mai dovremmo usare i nostri corpi preziosi e insostituibili per fare lavori più indicati per le macchine della catena di montaggio?” (pag.5 ).
L’indagine procede anche conversando con protagonisti della cultura di quegli anni, come W. Gibson, W.S.Burroughs, Winona Ryder e altri. La vastità e la natura degli esempi e dei campi d’indagine esposti non mi permettano una sintesi esauriente, nella scarsità di tempo che la pazienza del lettore/lettrice può concedere a me; basti dire che l’indagine del Leary esplora a 360 gradi, non solo, come ho già ricordato, l’intera coscienza dell’uomo, ma altresì l’intero corso evolutivo dell’umanità, nel momento appunto di questa svolta cruciale, il passaggio a una società basata sull’informazione.
Uno dei “leit-motiv” è comunque il rapporto autorità- individuo che il Leary (a mio parere, giustamente) risolve a favore di quest’ultimo, dopo averlo esaminato nella sua evoluzione storica. Il Leary è inoltre convinto che le moderne tecnologie faranno “pendere la bilancia” sempre più a favore di quest’ultimo, e ne espone esaurienti ragioni.
Coerentemente con questo, posso ricordare – e condividere – lo slogan dell’opera, sintetizzato con l’acronomo TFYQA ossia Think for yourself; question authority, grosso modo traducibile come: “Pensa per te stesso, metti in discussione le autorità”.
Per concludere lascio la parola all’autore medesimo:
“I proprietari di Personal Computer stanno scoprendo che il cervello è:
- l’organo definitivo del piacere e della consapevolezza;
- una matrice di cento miliardi di microcomputer che attendono il boot, l’attivazione, la stimolazione, la programmazione;
- in impaziente attesa di software, testaware, pensieroware, che ne riconosca l’impressionante potenziale e che renda possibile il collegamento elettronico in inter-rete con altri cervelli.”(4)
Il vostro affezionatissimo
(1)Timothy Leary, Caos e Cibercultura, Milano, Ed. Urra-Apogeo, 1996. Il titolo originale è “Chaos & Cyber Culture” ma evidentemente l’editore, (o, meno probabilmente: il traduttore) riteneva “troppo anglofono” per quegli anni, scrivere “cybercultura” con la y, dimostrando così poca preveggenza…. Comunque rimane una pregevole edizione, splendidamente illustrata, il cui principale difetto è l’assenza di un indice analitico….
(2) dal diario indiano della Kyger, presente nell’antologia “The Beat Book: poesie e prose della Beat Generation” a cura di Anne Waldman, Milano,il Saggiatore, 1996, pag. 227
(3) Purtroppo è piuttosto sconfortante notare come qualsiasi discorso, e la maggioranza dei testi sul tema “informatica, società e individuo” non esca dai due consueti binari, ossia la falsa alternativa del pessimista “Come internet sostituisce i rapporti umani” e dell’idiota apologia “Come internet ingrassi i profitti delle aziende, ossia dei soliti pescecani”.
(4) Op. Cit. Pag 50.
Have sex Hate sexism
Pubblicato: ottobre 20, 2013 Archiviato in: Uncategorized | Tags: varie 1 Commento